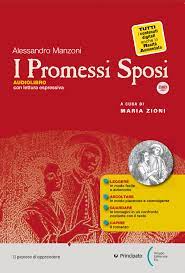PRESTO DI MATTINA
Il battito in ogni cosa
Chi sei tu?
«Chi è lo Spirito santo?» Non mi pare questa la giusta domanda da porre a Pentecoste. Sa troppo di ‘catechismo’, di dogmatica, finendo per indurre a una risposta impersonale, magari impeccabile, ma da manuale di teologia, che non quieta l’attesa di chi interroga né riesce veramente a dischiudere il segreto nascosto nel nome. Fatalmente, chi la pone si fermerà a metà strada, senza arrivare al cuore e sentirne il battito. La strada è un’altra.
A Pentecoste, al compiersi della Pasqua e al venire dello Spirito, una più congegnale domanda potrebbe essere: «Chi sei?», senza dimenticare di ripetere con ardente desiderio: «Chi sei tu per me?».
Solo quest’ultimo interrogativo rivela l’esperienza, come diceva Isacco il Siro (VII secolo) [Qui], senza accontentarsi di una risposta fors’anche erudita e ornata di bellezza, ma impersonale. Non è raro che si pongano domande prive di un contatto con la realtà. Ecco perché un interrogativo che suscita e proviene dall’esperienza è un tesoro in cui possiamo confidare.
In questa audace e ad un tempo confidente domanda: «Chi sei tu per me e chi sono io per te?» solo chi è amato e a sua volta ri-ama giungerà a conoscerne la risposta. Nel tu per tu della relazione, di una libertà che ad un tempo si fa accogliente e si affida all’altro, può venire alla luce la parola, il nome sempre conosciuto e nominato sempre in modo nuovo di colui che Riccardo di San Vittore [Qui] chiamava il «condilectus, amor debitus et donum», un amore condiviso che si riceve (debitus) e che si dona a sua volta oltre sé stesso.
«Con-dilectus» esprime la gratuità dell’accoglienza, il darsi di una comunione reciproca di un amore a due, quella del Padre e del Figlio. Lo Spirito è sì il luogo vivente del loro amore, dove entrambi dimorano; ma questo luogo è reso permanentemente aperto dallo Spirito santo.
È costui infatti amore in uscita, che non trattiene gelosamente ciò che riceve. È passione di amore che non resta passivo, ma diviene a sua volta azione di amore che permanentemente fluisce, sorgente che zampilla in ogni dove, anche dentro di noi: «l’acqua che io gli darò – dice Gesù alla samaritana riferendosi allo Spirito – diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14).
Il tutto a dimostrazione che la perfezione dell’amore non è esclusiva, ma inclusiva. Estasi di amore è lo Spirito, irruenza, dolcemente fluente, fuoco di amore, mite ardore di amore, che a Pentecoste mette sottosopra il cuore, e sparpaglia gli araldi del vangelo riunendo i linguaggi degli uomini, sino a renderli consonanti gli uni gli altri al loro messaggio, concordi come fratelli: «Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra» (Sal 103, 30).
Lo Spirito è così tanto libero amore da lasciare anche in dono la libertà di nominarlo in molti modi, in moltissime lingue. Tutti infatti lo conosceremo, dal più piccolo al più grande, nel modo in cui anche noi saremo da lui conosciuti.
Ad ispirarmi questi pensieri è stato un inno di Pentecoste scritto nella sua ultima esperienza di questa festa da Edith Stein [Qui], Teresa Benedetta della Croce carmelitana, prima di essere deporta ad Auschwitz. È Edith a domandarsi: «Chi sei?».
«Chi sei, dolce Luce/ che ricolmi il mio essere/ e rischiari/ l’oscurità del mio cuore. Inafferrabile, inconcepibile e incontenibile in un nome» e tuttavia «più vicino a me/ di me stessa/ e più intimo/ del mio stesso intimo. Eppur nessun ti tocca/ o ti comprende/ e d’ogni nome infrangi le catene. Mi conduci per mano/ come una madre/ e non mi abbandoni,/ altrimenti non saprei muovere/ più nemmeno un passo./ Tu sei lo spazio/ che circonda/ il mio essere/ e lo prende con sé».
Sussurri e battiti d’amore
«Ogni sussurro/ e battito d’amore,
ogni sussurro che acconsenta amore».
(G. Ungaretti [Qui])
Lo Spirito è il battito in ogni cosa, pietra o albero o sabbia o acqua che sia, in ogni vivente e in ogni parola soffio di vita. È «murmure tra gli ulivi saraceni». Un “murmure di mare” è la nostalgia di amore, che risveglia nel poeta il ricordo di lei, dell’amata, e in me – «come l’acqua delle fontane di san Pietro, murmure liturgico» – la «Dulcis Jesu memoria, vera cordis gaudia», affinché il Cristo continui ad essere anche per me dimora e cammino, e il suo vangelo sia giogo dolce e carico leggero.
Eco di Dio in ogni cosa è il suo Spirito: «Eco d’una voce chiusa nella mente/ che risale dal tempo; ed anche questo/ lamento assiduo di gabbiani: forse/ d’uccelli delle torri, che l’aprile/ sospinge verso la pianura. Già/ m’eri vicina tu con quella voce;/ ed io vorrei che pure a te venisse,/ ora, di me un’eco di memoria,/ come quel buio murmure di mare» (S. Quasimodo [Qui], Tutte le poesie, 101; 585; 141).
A Pentecoste lo Spirito santo sta proprio nel buio della notte come luce promessa. Come l’aurora, affioramento di luce, è già una promessa presente; già una preghiera esaudita: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre. Lo manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14, 16-26). Preghiera che continua a compiersi nel tempo: lo Spirito stesso prega con insistenza in noi, con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 26).
Lo Spirito, come l’aurora, è il battito del germinare della luce, chiarore che crea un varco nell’oscurità, battito del riposo nella fatica, tocco di rugiada nella calura, conforto di prossimità nel pianto.
Sulla soglia della decisione
Paraclito/Ad-vocatus = colui che è chiamato a sé, che è in-vocato per sostenerti nell’ora della decisione, confortarti nell’ora della prova. Tutta la vita – cristiana diceva san Serafino di Sarov [Qui] – è con-seguire lo Spirito santo, divenirne discepoli. Da lui viene il dono del consiglio, del discernimento spirituale, come pure del discernimento comunitario che è esercizio di sinodalità. È lo Spirito che guida al pensiero di Cristo, che è generativo del con-senso della fede dei battezzati nella comunità cristiana: sinfonia dei differenti battiti dei credenti.
Paolo ricorda ai Corinti che: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2, 9-16).
Pentecoste continua ad essere così il tempo della decisione. Lo Spirito santo ci attende sulla soglia, quella della decisione della libertà: abita in essa, per farci fazione, dalla parte del vangelo, consorti suoi. La soglia della decisione è anche il luogo dell’indecisione: luogo certamente comune dell’incredulità e della fede. È la soglia presso la quale egli ci attende.
È don Primo Mazzolari a dirci che lo Spirito ci fa essere «con la volontà e il cuore di fazione per il Regno del Padre. Troppa gente ha fretta di smobilitarci dai nostri ideali e dai nostri ricordi, per nuovamente intrupparci dietro interessi, che non sono neanche interessi: troppa gente ha premura di renderci gravosa la libertà così faticosamente guadagnata per disporci al baratto. Ancora una volta la nostra libertà cristiana per un piatto di lenticchie!» (Il Compagno Cristo, 42).
E in un’omelia, lo stesso Mazzolari ricorda le tentazioni del cristiano: «La Parola di Dio l’ho dentro di me, non la posso più rifiutare e adattare ai miei gusti, imborghesirla. Nel ‘lontano’ la ricerca è un istinto naturale; nel credente è istinto e grazia.
C’è poi il confronto continuo fra ciò che mi splende nella visione e nel desiderio e ciò che riesco a fissare. Penso in eternità e avanzo lentamente nel tempo. Ho ricevuto tanto e di tanto devo rispondere: anche davanti agli uomini. Sono creato testimonio davanti agli uomini. Dipende da me se Cristo sarà accolto o giudicato nella mia luce o nella mia tenebra. Sono di fazione per Lui fino all’ultimo respiro» (Domenica prima di Quaresima Mt c. IV, v. 1 –11).
L’espressione iniziale del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli: «mentre il giorno di Pentecoste stava per compiersi», quello “stare per compiersi” esprime il venire a maturazione della decisione degli apostoli, intuito dello Spirito e sua grazia, che a Pentecoste li farà testimoni del vangelo.
La stessa locuzione la troviamo anche nel vangelo di Luca al cap. 9, che narra il momento in cui Gesù manifesta la sua decisione di andare a Gerusalemme annunciando così la sua prossima passione: «Mentre stavano per compiersi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù indurì la sua faccia e partì direttamente verso Gerusalemme».
È l’inizio del grande viaggio e lo Spirito, urge in lui e lo sospinge a salire con i suoi verso Gerusalemme, sapendo che là lo attenderà la croce; quella decisione lo porterà a raggiungere tutti e a dare compimento all’amore: «quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me», ad abbracciare tutti, anche i nemici e nel luogo del suo innalzamento, da quel legno pure lui dai chiodi trafitto, colpo su colpo battuti, battito di un cuore morente e dopo aver preso l’aceto, reclinando il capo, avrebbe alla fine reso su tutti lo Spirito.
Lo Spiritus Principalis o Pneuma hegemonikon è l’energia di amore sorgiva che il Padre ha dato al Figlio e che questi ha rimesso nelle sue mani e donato anche a noi. È colui che conosce l’ordito dell’amore, l’ordo amoris, perché ne è il principio, la tessitura che regge e intreccia l’insieme dei fili di ogni amore fino al loro compiersi. È principalis, che inizia sempre, regge e guida ogni cammino, attacco e arrivo ad ogni movimento, filo dopo filo, battito dopo battito in ogni cosa, in ogni vita che acconsenta amore.
Spiritu principali confirma me (Salmo 50 [51], 14)
Tu esci
come da ferita del legno,
lavacro battesimale.
Tu sgorghi
come da cuore trafitto,
acqua e sangue,
vita nascente
da compiuta morte,
sigillo di un amore risorto.
Goccia a goccia dapprima,
fiume che travolge poi,
inondazione feconda
per l’arida fede
e per gli Undici,
sementi disperse
dal battito della paura.
Tu, primo battito
di un cuore di Chiesa
su cui accordarci
sempre di nuovo
perché si sia
cuore indiviso.
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]
Cover: Roma, p.zza San Pietro, fontana lato nord – Foto Wikimedia Commons