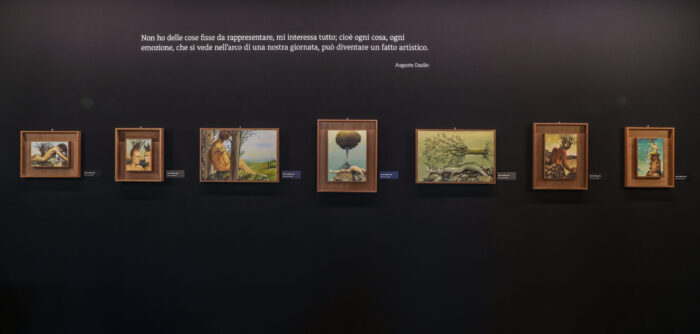Il cielo sogna la terra e nasce Maria; spunta il fiore del vento, l’anemone umile che alle prime piogge farà fiorire il deserto. Il cielo dice “Adusm”, presente, ci sono. La terra risponde “Eccomi”, son qua. «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca» (Is 35,1).
Sognare è andare verso un sapere dell’anima: un affacciarsi ed un ritirarsi, un dentro e un fuori; è un continuare a nascere, ferita aperta tra la notte del senso e il suo giorno, tra sapere e non sapere; la soglia non già di un luogo ma di una relazione, perché non basta essere nati e affidarsi la prima volta.
«Ogni volta che si nasce o si rinasce, perfino nel nascere di ogni giorno, occorre accettare la ferita nell’essere…
Viveva al futuro, o meglio nel futuro, non avendo presente. Era stata sul punto di cadere nel passato. Ma lo stesso passato, frammentario e doloroso, la respingeva. Si era decisa a nascere, ma avrebbe dovuto continuare a nascere…
Doveva portare in alto sé stessa attraverso il deserto, talvolta perdendo i sensi, cadendo in pozzi di silenzio, in negazioni. Vivere è una fatica che, in alcuni momenti, appare impossibile da compiere; la fatica di percorrere la lunga processione degli istanti, di opporre resistenza al tempo; resistere al tempo è la prima azione che l’essere vivi richiede; è sapere, poi, che il “qui” è molto concreto, molto definito e non lo si conosce» (Maria Zambrano [Qui], Delirio e destino, Milano 2000, 19.).
Solo attraversando di continuo dal dentro al fuori delle relazioni e dei sogni, si costituisce e prende forma quell’orizzonte in cui il sogno si risveglia, diventa reale; un sognare insieme è la realtà: «Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di sorgenti» (Is 41, 18).
Nella luce dell’aurora il sogno dalle tenebre si fa luce; su questo confine e soglia, che è passaggio dell’esistenza stessa, ci è dato comprendere il sogno come un continuare a nascere.
La scrittura stessa è onirica. I suoi segni grafici in attesa, al pari di germogli di sogno, divengono come anemoni nel deserto dell’arida pagina, simili agli anemoni scarlatti che ricoprono all’arrivo delle prime piogge il deserto del Negev nel sud della Palestina.
Ma un continuo venire alla luce sperimentano anche coloro che hanno come levatrice la lettura. Chi legge è come quei torrenti del Negev che, secchi e inariditi, d’improvviso la pioggia rigenera: aprendo un libro, essi si riempiono di acque impetuose, dei sogni del cielo raccontati dalle nubi portate dal vento, sino a che la terra arida, come lo spirito, fanno rifiorire.
Il sogno è “immenso fiume” che precede il nascere di nuovo. È la nascita come desiderio di ristabilimento delle sorti, promessa di una trasformazione. Un precedere è il sogno che fa procedere la vita, un passo dopo l’altro, perché nascere è un venire a sé stessi andando verso l’altro, un procedere verso chi ci precede innanzi.
«Ed ecco: la stella che avevano visto in oriente li precedeva» (Mt 2,9): il sogno dei Magi è il sognare dei popoli. «E ora andate e dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, ve l’ho detto» (Mt 28, 7): l’annuncio delle donne è il vangelo: il sogno nascosto nelle viscere di ogni vivente.
Sotto il deserto
Sterile nel tempo,
Procede fresco e lento
Un fiume immenso.
La terra gli fa largo,
E si pulisce;
La tenebra in letargo
Si spoltrisce.
Ogni goccia in sé raccoglie
Che filtrava esaurita,
E l’abbevera di vita,
Non più sola con la morte.
Ma di fuori sta il deserto
Senza avere giovamento:
Moltiplica la sabbia,
Ammucchia pietre e rabbia;
Ignora il fiume immenso,
Che se sporge in refrigerio
Dentro l’oasi feconda
Una cinta lo circonda,
E fa suo il desiderio.
*
Così il fiume torna ancora
Nel mister del proprio corso –
E per sé nemmeno un sorso.
***
Perde i pètali la rosa
Per spiegar le ali al volo:
Compie intanto il tuo sogno,
E la salute del ramo.
Chi cammina leva un piede
Mentre appena l’altro posa:
L’equilibrio è un richiamo,
E così il passo procede.
Io rimango, e tu mi lasci,
Come terra sfugge al sole
Perché tutta la fasci:
L’addio non è l’abbandono.
(Clemente Rebora [Qui], Le poesie, Milano 1994, 157-158; 479).
L’Assunta: un destino sognato
Scrive Maria Zambrano: «Ombre del sogno di Dio. La mia vita non è il mio sogno e se la sogno è perché io che la sogno vengo sognato. Dio ci sogna e allora dobbiamo rendere il suo sogno il più trasparente possibile, ridurre l’ombra al minimo, assottigliarla. Dio mi sogna? Sarà possibile realizzare il suo sogno? …
Forse Dio sognò di una sua creatura, la prediletta; forse l’universo ci sogna come suo compimento e siamo già sognati, pre-sognati nel fiore e nell’albero che si erge, nella stessa materia estesa, sognata a sua volta, che aspira alla realtà e si mette a servizio per raggiungerla» (ivi, 16-17).
L’Assunta è il sogno di Maria, è quell’addio che non abbandona; un saluto – invece − di prossimità, perché l’a-deus è un abbraccio che ritorna sempre, di nuovo, da parte di colei che ci ha preceduto in una nuova nascita, quella della sua ultima Pasqua, il passaggio nella beatitudine del Figlio.
Disse di lei Elisabetta, sentendo sussultare il suo grembo gravido: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1, 45).
Innalzata è Maria, come il Figlio, risorta nel Risorto − potremmo dire pure − poiché il verbo greco eghéirô corrisponde ad alzare, rialzare, innalzare, sorgere: ma è anche il verbo della risurrezione, quello a cui ricorrono gli evangelisti per descrivere lo status del Crocifisso risorto: “in piedi”.
Da Maria e dal suo popolo, Gesù ha imparato a sognare il sogno di Dio per continuare a far nascere la vita attraverso i suoi sogni, che sono le sue parabole, a rialzarla nei suoi gesti di guarigione prendendola per mano.
Per questo nelle icone bizantine della Dormitio – come è chiamata in Oriente l’“Assunta” – è raffigurato Gesù che tiene sulla mano una piccola Maria, così come quest’ultima aveva tenuto quella del figlio appena nato.
Sogno vivente, quello di Gesù, incarnato nell’orizzonte della realtà e della storia. Ritorna infatti il verbo egheiretai, surgit a cena: «si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto» (Gv 13,4-5).
Lo stesso è stato per Maria dopo l’annunciazione, dopo il suo eccomi all’adsum del cielo. “Exsugens autem Maria, abiit in montagna”. Qui, in Luca 1, 39 troviamo un altro verbo della risurrezione: «‘Anastãsa de Maria»:
«In quei giorni Maria si alzò in fretta», tutta incinta del suo sogno per recarsi verso la montagna dalla cugina Elisabetta, pure lei incinta del suo impossibile sogno: un figlio nella vecchiaia.
Giovanni, sarà il suo nome: grazia e dono di Dio. Anístêmi è il verbo che significa risvegliare, far alzare, innalzare, far risorgere da morte; e Anastasi viene detta nell’iconografia bizantina l’icona della risurrezione e della discesa agli inferi di Cristo.
Il sogno di Maria è il sogno dei poveri, degli afflitti, dei miti, degli affamati e assetati, dei perseguiti a causa della giustizia, dei misericordiosi, dei pacifici e di coloro che hanno il cuore limpido: il sogno degli uomini e delle donne delle beatitudini.
Maria, la ragazza di Nazaret, ne ha piena consapevolezza quando risponde ad Elisabetta con il canto del Magnificat: ha guardato all’umiltà della sua serva… ha deposto i potenti dai troni “ha innalzato i tapini” «hupsôsen tapeinoús», i piccoli, gli umili.
Ancora un altro verbo per dispiegare, oltre tutti i confini e le barriere, l’ampiezza e la smisuratezza del sogno dell’Assunta. Mi riferisco al verbo hupsoô, che significa alzare in alto; elevare alla sommità di opulenza e prosperità; esaltare, elevare a dignità, onore e felicità.
Ma così l’Assunta ha preceduto ogni cristiano nella pratica delle beatitudini del regno, parimenti è colei che per prima nella peregrinazione della fede, accompagna tutta la Chiesa.
Del resto la prima beatitudine è proprio quella del credere e del praticare il sogno del vangelo. Non per caso, sul monte delle Beatitudini, Gesù pronuncia l’Adsum qui sulla terra, il suo eccomi qui, tra la gente: «Al tramontar del sole, tutti quelli che avevano dei sofferenti di varie malattie, li conducevano a lui; ed egli li guariva, imponendo le mani a ciascuno» (Lc 4,40).
Da dove comincia allora la sequela di Maria nella pratica delle beatitudini? Innanzitutto bisogna impararle a memoria non diversamente conosciamo il Padre nostro. Ci vuole così poco − credetemi − basta volerlo.
È come imparare una poesia. Ma perché una poesia diventi un sogno che risveglia, che continui a farci nascere, occorre un’interiorità spaziosa, resa libera dalla premura, come grembo materno umile e ospitale.
L’umiltà − dice Nikolaj Berdiaev [Qui] − è una delle vie della libertà. Lungi dal corrispondere a sottomissione della volontà ad una volontà estranea, l’umiltà è l’atto dell’uomo orientato verso se stesso tanto da presupporre una intensa libertà dello spirito.
«Essa è la via che conduce alla liberazione dal potere di tutto ciò che è arbitrio, esteriore, estraneo all’uomo; la via che conduce alla libertà dello spirito, al rifiuto di ogni dominio degli elementi asservitori, a quella libertà interiore che trionfa del male nella vita» (Nikolaj Berdjaev, Spirito e libertà, Edizioni di Comunità, Milano 1947, 217-218).
E se l’umiltà è l’ospitalità che uno fa di sé al sogno dell’altro, ecco che praticare le beatitudini significherà mettersi dalla parte degli uomini e delle donne delle beatitudini nella forma di una diakonia sinodale.
Svegliarsi è rinascere ogni giorno: un risvegliare il sogno
«E imparò a svegliarsi alle prime luci del giorno per vedere, per un istante, attraverso il balcone aperto alla neve, l’alba, luce immemore che benedice il nostro sogno.
Svegliarsi è rinascere ogni giorno. E la luce già ci attende. È già lì, iniziata, la storia che ci tocca proseguire. Svegliarsi è entrare in un sogno già in movimento, provenire dal deserto puro dell’oblio ed entrare, per prima cosa, nel nostro corpo, ricordarlo senza rancore, entrare ad abitarlo e a recuperare la nostra anima con la sua memoria, la nostra vita con le sue occupazioni. Entrare come in un bozzolo tessuto da innumerevoli affaccendati bruchi; riprendere la nostra freddezza nel bozzolo fabbricato instancabilmente dal bruco-uomo, facitore di sogni che si realizzano, costruttore di storia». (Zambrano, ivi, 63).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]