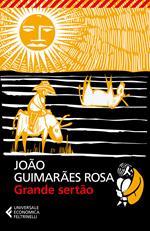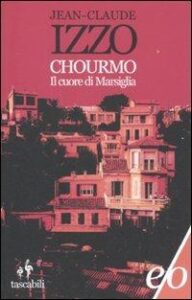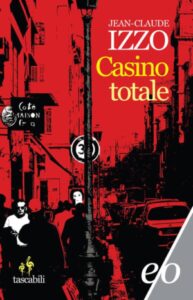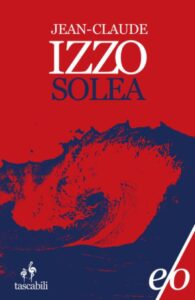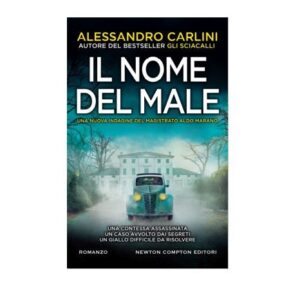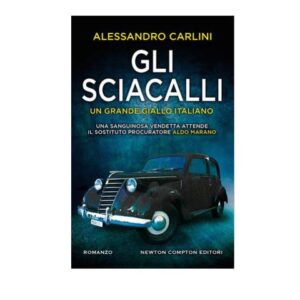PRESTO DI MATTINA /
Un albero in cammino
Sementi autunnali di un libro appena chiuso,
già germogliano in un altro,
non ancora aperto.
Così ho pensato, attraversando con Bashō [Qui] Lo stretto sentiero del profondo nord. Giunto all’ultima pagina, mi è affiorato alla memoria il frontespizio di un altro libro − un testo sulla speranza di Gabriel Marcel [Qui], “Homo viator”. Prolegomeni ad una metafisica della speranza, Borla, Torino 1967 – che lessi tanti anni fa e a cui dedicai un articolo sulla rivista Palestra del Clero nel 1983. Come se un viaggio appena terminato germogliasse subito in un altro inizio.
Dice un detto antico: Homo viator, spe erectus. Un viandante è l’uomo, innalzato dalla speranza, che cammina eretto verso un oltre cui non può resistere a lungo. La speranza è fragile apparizione, come una striscia di haiku, uno spazio ristretto che nell’aprirsi subito si richiude.
L’haiku, pura immediatezza dell’impressione di incontri, di luoghi, di stagioni, di minute e quotidiane presenze colte nell’attimo del loro mostrarsi lungo il cammino o la sosta. Breve il suo dire, non descrizione né ragionamento, ma forza di movimento che fa avanzare dentro sé e fuori, verso l’oltre. Immagine di nitidezza: istantaneità di un lampo.
Come l’haiku la speranza assomiglia nell’uomo allo spazio piccolo di una conchiglia, in cui il vento continuamente muove il rumore dell’infinito mare.
Come l’haiku «è il coagularsi di una intuizione estetica possibile solo quando il soggetto, dopo un lungo apprendistato, riesce a scomparire d’un tratto per lasciare posto all’oggetto, all’evento, quasi cifra in cui si concretizzano la leggerezza, la rapidità, l’esattezza, visibilità e la leggerezza» – scrive Elena Dal Pra – così la speranza è il coagularsi dell’esistenza, non come un problema da risolvere ma, al fondo della sua problematicità questionante, come mistero da accogliere; dimentichi di se stessi si scompare per lasciare il posto all’altro, attimo di presenza: risonanza di un altrove.
“Arbor viator”
Un albero in cammino, fattosi errante viaggiatore. Queste le parole affiorate subito dopo, ritornando con il pensiero a Matsuo Munefusa (Ueno 1644-Dsaka 1694), colui che cambiò il suo nome in Bashō, una pianta resistente al grande freddo e dalle cui fibre si ricavano tessuti pregiati.
Scelse questo nome quando un inverno egli ricevette dal suo discepolo una pianta di Bashō, il banano orientale giapponese. Lo piantò nel giardino di casa che i discepoli iniziarono a chiamare “eremo del Bashō”, tanto che da allora egli prese a firmare i suoi haikai con questo nome, portando il quale egli si mise in viaggio nel 1689, avanzando con fatica per la pena del distacco. Questo è l’haiku con il quale inaugurò il suo taccuino:
La primavera passa
triste il canto degli uccelli,
negli occhi dei pesci, lacrime
alla stanchezza non manca sollievo di stupore
stanchezza:
entrando in una locanda,
i glicini
Da quel giorno non si fermò più. Percorse 2.400 chilometri da sud al nord del Giappone. Come un eremita errante, Bashō si avvicinò in questa itineranza al buddhismo zen, la memoria dei luoghi, i paesaggi, i santuari, montagne sacre, le tombe degli antichi, la stessa poesia sono le sue mete, da cui poi nuovamente ripartire.
Ricorda ancora Elena dal Pra: «si sposta apparentemente senza uno scopo, calcando le tracce dei poeti del passato, visitando templi, e dispensando la sua sapienza ai poeti che incontra sulla sua strada, in una ricerca di ascesi che passa attraverso la fusione con le cose piccole della natura e con il fluire dei suoi tempi, e attraverso una solitudine e una povertà che sole possono permettere questa fusione», (E. Dal Pra, Haiku, Mondadori, Milano, 34).
Pioggia d’inverno
sarò chiamato anch’io
viaggiatore.
Strada facendo nella stagione delle piogge, non c’è ormai più differenza tra lui e la pianta di bashō.
Un banano nel temporale
Il gocciolio dell’acqua nel catino
Scandisce la mia notte
Verde
riverbera il banano
sui pannelli di carta di riso
Non compare l’ideogramma della parola speranza, così mi è sembrato. Essa forse è nascosta, o da cercarsi in ogni segno, in ogni immagine in cui segretamente dimora.
A me è sembrato così che ogni cosa fosse illuminata di speranza dal di dentro: “in mezzo al campo/ il canto libero/ dell’allodola”;
anche i colori la manifestano silenziosamente: “Inizio d’autunno:/ nel mare e nei campi/ un verde solo”;
è nascosta in una foglia: “cade una foglia di paulonia -/ perché non vieni/ nella mia solitudine?”;
perfino la troviamo nello scrosciare delle cascate: “chiare cascate:/ tra le onde si infilano verdi/ gli aghi dei pini”; “la cascata Shiraito -/ Filo Bianco – / scorre in mezzo al fogliame verde”;
compare sulla mensa: “fragranza dei fiori di pruno:/ sotto il naso dell’ospite/ una ciotola verde mare”.
Nella forza di sognare essa rincuora il poeta ammalato: “Ammalatomi in viaggio/ il mio sogno corre ancora/ qua e là nei campi spogli”. Perfino da un ciliegio tardivo non si lascia dimenticare, essa è nascosta come fuoco, nei suoi fiori sotto la neve per dischiuderli:
“Mi sono appoggiato a una roccia per un momento di sosta, quando ho notato un ciliegio alto appena tre shaku (1= 30,303 cm) con i boccioli in parte schiusi. Anche se coperti da una coltre di neve, i fiori del ciliegio tardivo non dimenticano l’arrivo della primavera: come erano aggraziati! Era come avvertire il profumo dei pruni sotto un cielo infuocato”.
Ma forse il luogo profondo, abisso, in cui è nascosta la speranza è nell’ideogramma delle lacrime. Sono la compagnia dell’homo/arbor viator, della sua condizione di sofferenza, di insoddisfazione e di ricerca, di impermanenza in un luogo e, al contempo, della sua infinità che lo attira fuori di sè.
Le lacrime sono l’attimo transitorio ed insieme l’eternità. È nelle lacrime che si attarda, si sofferma la speranza come un residuo inamovibile, grumo resistente in ogni ferita.
“Li vicino, in un antico tempio, si trovano le pietre tombali della famiglia Satò. Tra tutte, le più struggenti erano quelle di due donne andate in sposa alla famiglia Satò. Sono passate alla storia per il loro eroismo, pur essendo donne. A questo pensiero, le maniche della mia veste si sono impregnate di lacrime. Non bisogna viaggiare lontano, fino in Cina, per trovare lapidi che inducono al pianto”.
Dopo aver visitato le tre montagne della nascita, della morte e della rinascita, vita morte vita, Bashō scrive “Tornato al tempio, per richiesta dell’abate, ho scritto sui tanzaku (striscia di carta stretta e lunga) tre poesie composte nel mio pellegrinaggio lungo i tre monti.
Frescura!
Pallido spicchio di luna crescente
sul monte Haguro.
Si sbriciolano
le cime delle nubi
Monte Della Luna.
Come posso parlare
di Yudono, maniche
bagnate di lacrime.
Davanti alla sepoltura di un poeta scrive:
Smuoviti, tomba!
È la mia voce che piange
questo vento d’autunno.
E guardando una ciocca di capelli della madre morta:
la prendessi in mano
si scioglierebbe nelle mie lacrime
come brina d’autunno.
Se tu ti dimentichi della speranza, la speranza non dimenticherà te, perché non si spera da soli. Non dimenticare allora chi ha sperato e spera con te e anche per te. Qui, alla partenza di un discepolo, Bashō si paragona ai fiori del susino rosseggianti che restano nascosti nel bosco.
Non ti dimenticare
i fiori del susino
in mezzo al bosco.
Io spero in te per noi
Questa intuizione profonda di Gabriel Marcel non l’ho più dimenticata da quando la lessi per la prima a volta nel 1983 in Homo viator. Tanto che spesso mi sale alle labbra come una supplica, e d’improvviso l’angolo della preghiera si apre sullo stretto sentiero del profondo nord, cercando la speranza nascosta tra la gente:
«“Io spero in te per noi”: questa è forse l’espressione più adeguata e più elaborata dell’atto che il verbo sperare traduce in maniera ancora confusa e velata. In te – per noi: qual è dunque il legame vivo che esiste tra questo te e questo noi che soltanto il pensiero più profondo riesce a scoprire nell’atto di sperare? Non si deve rispondere che Tu sei in qualche modo il garante di questa unità che lega me a me stesso, oppure l’uno all’altro, gli uni agli altri?
Più che un garante che assicurerebbe o confermerebbe dall’esterno un’unità precostituita, Tu sei il cemento stesso che ne costituisce il fondamento. Se è così, disperare di me o disperare di noi, significa disperare di Te.
Certo, è logico che vi sia qualche difficoltà nell’ammettere che io formo con me stesso una comunità reale, un noi: solo a questa condizione tuttavia io partecipo allo spirito come fonte d’intelligenza, d’amore e di creazione.
Questo Tu assoluto nel quale debbo sperare, ma che ho sempre anche la possibilità, non astratta ma effettiva, di rinnegare, è il fulcro del mondo che io formo con me stesso e che – l’esperienza ce ne offre la tragica testimonianza – rimane investito del potere di auto-incenerirsi…
Se è così, bisogna dire che sperare, come noi presentiamo, significa vivere nella speranza, anziché concentrare la nostra ansiosa attenzione sulle poche monete d’argento allineate dinanzi a noi, delle quali febbrilmente, incessantemente facciamo e rifacciamo il conto, attanagliati dal timore di averne meno del previsto o di trovarcene senza…
“Io spero in te per noi”, tale è la formula autentica della speranza. Ma se questo “per noi”, anziché aprirsi su un infinito, tende a rinchiudersi su sé stesso, la speranza appassisce e si snatura» (Homo viator, 72-73; 109).
Vivere la speranza come il fiume del cielo: di traverso alla terra
Ama-no-gawa, il fiume del cielo, è la Via Lattea.
O burrascoso mare!
traverso all’isola di Sado
si stende il Fiume del Cielo.
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]