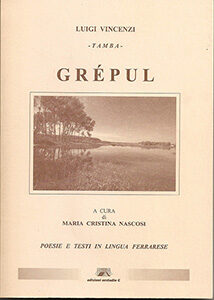di Guido Viale
Trovo completamente sviante la facile identificazione tra rifiuto del vaccino (o di questo vaccino) e l’egoismo individualistico di stampo ‘neoliberista’. È un bersaglio di comodo che non ci porta lontano, ma che porta lontano altri.
Ieri Theresa May auspicava la creazione di un ambiente ostile agli immigrati per ‘risolvere’ il problema dell’immigrazione. Oggi l’ambiente ostile lo promuove, con pubblica dichiarazione, Macron nei confronti dei no vax, per risolvere quello della pandemia.
In Italia lo si sta facendo da tempo con successo – con o senza pubbliche dichiarazioni – nei confronti di entrambi, migranti e no vax. Quale sarà il prossimo bersaglio?
Vero è che molti cosiddetti no vax fanno altrettanto, se non peggio, nei confronti di medici ‘vaccinisti’ e di infermieri impegnati nel loro lavoro. Ma non sono investiti di poteri pubblici né del favore della quasi totalità dei media. Il che è una differenza di cui tener conto… Il risultato è una crescente incomunicabilità tra le due ‘parti’, che si guardano in cagnesco.
Nell’arcipelago no vax ci sono molte componenti. Innanzitutto, nazisti e cattolici ‘tradizionalisti’ – quasi la stessa cosa – con finalità palesemente strumentali, che hanno gioco grazie al disinteresse e alla renitenza nell’interpretare le motivazioni di quell’arcipelago da parte di chi, come noi, avrebbe invece tutto l’interesse per cercare di farlo.
Poi c’è una vasta schiera di persone dalle convinzioni solide (già emersa quattro anni fa, in occasione delle mobilitazioni contro i dieci vaccini obbligatori della Lorenzin) per le quali il rifiuto dei vaccini, di tutti i vaccini, come di molti farmaci di sintesi riconosciuti dalla medicina ufficiale, fa parte di un regime di vita fatto di sobrietà, di cibo biologico, di lotta contro l’inquinamento dei campi e dell’ambiente, di rispetto e di ascolto della natura e del vivente.
Un regime che non è mai il frutto di scelte e meno che mai di pratiche individuali, ma di forme di condivisione che le costituiscono in comunità basate su mutualismo e solidarietà: pratiche da cui abbiamo tutto da imparare. Far passare le loro scelte per individualismo ed egoismo neoliberista è una manifestazione di insipienza.
Poi c’è una platea molto ampia di persone non organizzate che ce l’hanno con il governo e che hanno trovato nelle manifestazioni no vax – in mancanza di altri ‘attrattori’ sociali credibili – il modo di sfogare la loro rabbia in modo disordinato e a volte grottesco.
Non si spiega altrimenti la perseveranza con cui hanno continuato a ritornare in piazza. Tra loro troviamo ‘collettivi’ tutt’altro che egoisti – per lo meno in senso individualistico, ancorché li si potrebbe, per me a torto, giudicare ‘corporativi’ – come i portuali di Trieste e quelli di Genova (che, ricordo, hanno organizzato diversi scioperi contro il transito di armi, per questo lodati anche dal Papa, ma da chi, altri?).
Poi c’è una schiera di ‘sbandati dei social’, pronti a bere e a divulgare le più varie e spesso più stupide (ma non sempre) teorie complottiste. Hanno facile accesso alle altre componenti dell’arcipelago che è tutt’altro che impermeabile a molte delle loro teorie, ma che certo non si risolve in esse. Ma è un motivo per lasciar loro campo libero?
Occorre tener conto, però, che l’universo no vax, presente in tutto l’Occidente (del resto del mondo non so) è molto più vasto di quel 10-15% di italiani non vaccinati, perché comprende anche molti che si sono visti costretti a vaccinarsi, ma che nutrono nei confronti dei vaccini, delle misure governative e del governo lo stesso rigetto dei no vax praticanti.
E qui, più che i sondaggi contano i discorsi che si sentono in tram o al bar. E più che i nazisti, di cui non bisogna mai dimenticare presenza e minacce, conta una sempre più ampia sovrapposizione tra le aree, tacite o dichiarate, del non voto e quella del no vax. D’altronde, come dar loro torto?
Non è difficile vedere nelle decisioni contradditorie e contraddette dei governi – e soprattutto dell’ultimo, quello in carica – non il carattere sperimentale e necessariamente mai definitivo dei risultati della ricerca scientifica, bensì il semplice compromesso tra gli interessi personali, elettorali e lobbistici di uomini come Salvini, Brunetta o Renzi, ma anche Letta o Speranza (più molti altri; Draghi, d’altronde, non è da meno e ci ha messo pochi mesi per omologarsi al gruppo).
Perché, di molti dei tanti medici-scienziati che fanno le star in TV viene spesso da pensare che siano loro e la loro ‘scienza’ ad adeguarsi alle scelte dei politici piuttosto che il contrario.
Errori ne sono stati fatti molti e molti erano inevitabili, ma alcune scelte non sono errori ma crimini o inganni: innanzitutto il rifiuto di liberalizzare i brevetti sui vaccini, a cui il governo italiano si è allineato, nonostante la cosa sia consentita dal WCO.
Era chiaro fin dall’inizio, una volta messo a punto un vaccino, che per impedire la circolazione e la mutazione del virus era necessario vaccinare nel più breve tempo possibile il numero più alto possibile degli abitanti del globo. Uno sforzo e un costo eccessivo?
Quanto sono costate – lo chiedo ai cultori e agli adoratori del PIL – le perdite di PIL di due anni rispetto al costo di un intervento a tappeto a livello mondiale (risparmiando, per carità, tutti coloro che non vogliono vaccinarsi, ma consentendo a tutti gli altri di farlo)?
Le varianti che oggi tornano ad aggredirci, riportandoci al punto di partenza, non sono che la conseguenza di questo mancato intervento. Ma quanti medici-scienziati ce lo ricordano nelle loro quotidiane comparse in TV e sui giornali?
Poi l’aver agitato il miraggio dell’immunità di gregge a livello nazionale, bloccando qualche volo internazionale o imponendo qualche tampone ai confini: pura fuffa. Poi l’aver fatto credere – con tanto di supporto scientifico – che una volta vaccinati non si era più né contagiosi né contagiabili e aspettando mesi prima di lasciare intendere – senza mai dirlo apertamente – che il vaccino difendeva sì, per lo più, dalle forme più gravi della malattia, ma non dal contagio.
Così si è messa ‘in libera uscita’ un popolo di vettori del contagio ben più influente di quella misera percentuale di non vaccinati che, se l’immunità di gregge non fosse una chimera, non avrebbe alcuna possibilità di infettare il resto della popolazione.
Poi, evitando accuratamente di finanziare tutte le misure che avrebbero potuto ridurre la circolazione del virus con un vero distanziamento: per esempio, requisire locali per farne aule scolastiche, in attesa di costruirne di nuove, e assumere all’istante – non stanno forse governando in deficit? – un numero adeguato di insegnanti (che, a differenza dei medici, sarebbero già disponibili).
Moltiplicare i mezzi pubblici e le loro corse per portare gli studenti a scuola in sicurezza – non sono forse loro, la Next Generation EU, i destinatari di tutti quei fondi? – e anticipare così un futuro in cui il mezzo condiviso dovrà avere il sopravvento – se la transizione ecologica ha un senso – su quello individuale.
Invece hanno gettato miliardi e miliardi di euro in progetti di infrastrutture di trasporto senza senso, sia ora che, ancora di più, in futuro. Poi evitando di rafforzare la medicina territoriale (e la formazione dei medici): quella che, come dimostrato, intervenendo per tempo dopo i primi sintomi, può evitare l’ospedalizzazione e l’inevitabile aggravamento dei contagiati.
Lo si dice da due anni, ma non si è fatto quasi niente. Niente è stato fatto per portare alla pubblica discussione i casi di risoluzione positiva del contagio con interventi farmacologici tempestivi.
Poi, poi, poi… La gente non è scema, e queste decisioni, dettate da interessi consolidati, si sono riflesse sul credito dei medici-scienziati che le hanno avallate o non le hanno adeguatamente denunciate.
Guido Viale
Guido Viale è nato a Tokyo nel 1943 e vive a Milano. Ha partecipato al movimento degli studenti del ‘68 a Torino e militato nel gruppo Lotta Continua fino al 1976. Si è laureato in filosofia all’università di Torino. Ha lavorato come insegnante, precettore, traduttore, giornalista, ricercatore e consulente. Ha svolto studi e ricerche economiche con diverse società e lavorato a progetti di cooperazione in Asia, Africa, Medioriente e America Latina. Ha fatto parte del comitato tecnico scientifico dell’ANPA (oggi ISPRA). Tra le sue pubblicazioni: Un mondo usa e getta, Tutti in taxi, A casa, Governare i rifiuti, Vita e morte dell’automobile, Virtù che cambiano il mondo. Con le edizioni NdA Press di Rimini ha pubblicato: Prove di un mondo diverso, La conversione ecologica, Si può fare e Rifondare l’Europa insieme a profughi e migranti. Con Interno4 edizioni ha pubblicato nel 2017, Slessico Familiare, parole usurate prospettive aperte, un repertorio per i tempi a venire. Sempre con Interno4 Edizioni nel 2018 ha pubblicato l’edizione definitiva e aggiornata del suo importante libro sul ‘68.
NOTA: questo articolo con la medesima foto di copertina è stato pubblicato pressenza – International Press Agency il 08.01.2022