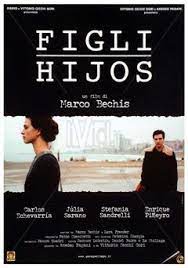“Negoziare, finirla con il pensiero unico e la propaganda, aiutare l’Ucraina a ritrovare la ragione e la Russia ad uscire dal tunnel della sindrome da accerchiamento non con le chiacchiere ma con atti concreti.”. E’ il pensiero di Fabio Mini, generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, già Capo di Stato Maggiore del Comando NATO del Sud Europa e comandante della missione internazionale in Kosovo. “E quando la crisi sarà superata, sperando di essere ancora vivi, Italia ed Europa dovranno impegnarsi seriamente a conquistare quella autonomia, dignità e indipendenza strategica che garantisca la sicurezza europea a prescindere dagli interessi altrui“
Dal Golfo di Tonchino alle armi di distruzione di massa in Iraq – e tornando anche molto indietro nella storia – Generale nel suo libro “Perché siamo così ipocriti sulla guerra?” Lei riesce brillantemente a ricostruire i falsi che hanno determinato il pretesto per lo scoppio di diverse guerre. Qual è l’ipocrisia e il falso che si cela dietro il conflitto in corso in Ucraina?
Il falso è che la guerra sia cominciata con l’invasione russa dell’Ucraina. Questo in realtà è un atto nemmeno finale di una guerra tra Russia e Ucraina cominciata nel 2014 con l’insurrezione delle provincie del Donbas poi dichiaratesi indipendenti. Da allora le forze ucraine hanno martoriato la popolazione russofona ai limiti del massacro e nessuno ha detto niente. Per quella popolazione in rivolta contro il regime ucraino non è stata neppure usata la parola guerra di liberazione o di autodeterminazione così care a certi osservatori internazionali. E’ bastato dire che la “Russia di Putin” voleva tornare all’impero zarista per liquidare la questione. L’ipocrisia è l’atteggiamento della propaganda occidentale pro-Ucraina che, prendendo atto che esiste una guerra, finge di non sapere chi e che cosa l’ha causata e si stupisce che qualcuno spari, qualcun altro muoia e molti siano costretti a fuggire. Ipocrisia ancor più grave della propaganda è il silenzio omertoso di coloro che tacciono sul fatto che dal 2014 Stati Uniti e Nato hanno riversato miliardi in aiuti quasi interamente destinati ad armare l’Ucraina e migliaia di professionisti della guerra per addestrare e arricchire i gruppi estremisti e neo- nazisti.
Nella stampa occidentale si tende a definire Putin come “un pazzo che ha scioccato il mondo con la sua iniziativa”. Eppure in un video del 1997 l’attuale presidente americano Biden dichiarava come l’allargamento ai paesi baltici (non all’Ucraina!) della Nato sarebbe stato in grado di generare una risposta militare della Russia. Non crede che dal 2014 l’Europa abbia sottovalutato la questione ucraina?
Non credo sia stata sottovalutata, ma è stata volutamente indirizzata verso la trasformazione graduale del paese in un avamposto contro la Russia, a prescindere dalla sua ammissione alla Nato. Di qui la pseudo rivoluzione arancione “ (2004), il sabotaggio interno ed esterno di ogni tentativo di stabilizzazione, l’alternanza di governi corrotti, la pseudo rivolta di Euromaidan, il colpo di stato contro il presidente Yanukovich (2014) fino alla elezione di Zelensky. Quest’ultimo è passato da un programma elettorale contro gli oligarchi, contro la corruzione politica e la promessa di “servire il popolo” ad una politica dichiaratamente provocatoria nei confronti della Russia. E questo era esattamente ciò che volevano gli Stati Uniti e quindi la Nato dal 1997.
Il tema dell’espansione Nato però è sempre stato tabù da noi…
L’espansione della Nato a est iniziata in quell’anno dopo una serie di prove di coinvolgere nella “cooperazione militare “i paesi dell’Europa orientale ( programma “Partnership for peace”) è stata una provocazione continua per 24 anni. Per oltre un decennio la Russia non ha potuto opporsi e la Nato, sollecitata in particolare da Gran Bretagna, Polonia e repubbliche baltiche ha pensato di poter chiudere il cerchio attorno ad essa “attivando” sia Georgia sia Ucraina. La Russia è intervenuta militarmente in Georgia e questo ha dato un segnale forte agli Usa e alla Nato, che non hanno voluto intervenire. Durante la crisi siriana del 2011 la Russia si è schierata con il governo di Bashar Assad e successivamente con la guerra all’Isis è intervenuta militarmente dando un contributo sostanziale alla sua neutralizzazione. Bashar Assad è ancora lì. Le operazioni russe in Siria ancorchè concordate e coordinate sul campo con la coalizione a guida americana, hanno disturbato i piani di chi voleva approfittare dell’Isis e delle bande collegate per destabilizzare l’intero Medioriente. Un altro segnale del mutato umore russo è stata l’annessione della Crimea subito dopo il colpo di stato contro Yanukovic sostenuto dagli Stati Uniti e in particolare dall’inviata del Dipartimento di Stato Victoria Nuland e dall’allora vice presidente Biden. Dal 2014 in poi l’Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti e della Nato ha assunto una linea ancora più ostile nei confronti della Russia e iniziato ad integrare nelle forze armate e nella polizia i gruppi neonazisti che si erano “distinti” negli scontri di Maidan. Gli stessi che ora organizzano la “resistenza ucraina” e coordinano i circa 16000 mercenari sparsi per il paese. Per tutto questo mi sento di dire che la Nato non ha trascurato l’Ucraina, anzi l’ha spinta con forza in un’avventura pericolosa per entrambi e soprattutto per noi europei.
In una recente apparizione in TV Lei ha detto di aver avuto modo di conoscere in prima persona i generali russi e ha definito quella russa “una guerra limitata per scopi limitati”. Quali sono gli obiettivi che i russi si sono posti sul territorio secondo lei?
In Kosovo avevo alle dipendenze anche il contingente russo di cui una parte garantiva sicurezza dell’aeroporto militare/civile di Pristina e un’altra schierata nel settore montano al confine con la Serbia. I rapporti con i generali russi erano quasi giornalieri e sempre molto corretti soprattutto nei miei confronti (in quanto italiano). Parlavamo di sicurezza collettiva e di futuro del Kosovo, una cosa alla quale nessuno nella Nato aveva pensato prima di andare in guerra. Parlavamo anche di operazioni militari e di dottrina. Vent’anni fa. La guerra limitata è una categoria prevista anche da Clausewitz e i russi sono sempre stati clausewitziani. All’inizio dell’invasione ho cominciato a vedere i segni non di una operazione speciale come l’ha definita Putin, ma di una serie di operazioni ad obiettivi limitati, unite dallo scopo strategico di impedire all’Ucraina di diventare il fulcro della minaccia militare alla Russia , ma tatticamente indipendenti. Le operazioni riguardavano la messa in sicurezza di territori del Donbass, la fascia costiera del mare d’Azov e del Mar Nero fino a Odessa e, se necessario, fino al confine con la Moldavia neutrale. L’avanzata su Kiev doveva essere l’operazione principalmente politica di pressione per i negoziati e l’eventuale instaurazione di un governo favorevole alla linea russa. Questa operazione non vincolata né al tempo né agli obiettivi: dipende dagli eventi. Se quelli diplomatici, politici e operativi evolvono in maniera soddisfacente l’operazione può essere interrotta. In caso contrario, dalla marcia d’afflusso le forze possono passare allo schieramento attorno alla città, e se ancora gli eventi sono negativi possono passare alla “preparazione” di fuoco poi al fuoco aereo e poi se e quando la città è allo stremo potrà iniziare la presa vera e propria della città. Questo tipo di operazioni con la tecnica del carciofo ha spiazzato tutti gli analisti della domenica che si aspettavano e forse cinicamente si auguravano di vedere la tempesta di fuoco alla quale ci hanno abituato gli americani in tutte le loro guerre. Ovviamente questa incredulità ha alimentato le speculazioni sull’effettiva potenza dell’apparato russo e sulla eroica resistenza ucraina che avrebbe arrestato l’invasione. L’apparato che vediamo in televisione dice però una cosa diversa: l’operazione è ancora intenzionalmente alla prima fase, in attesa di eventi. In questa situazione i vantaggi vengono soltanto dall’efficacia e credibilità della pressione. Gli svantaggi riguardano sia le provocazioni esterne (da parte della Nato) sia il rafforzamento della resistenza interna che non muterebbe il risultato dell’operazione ma farebbe molti più danni.
Ritiene che le armi che l’Italia invierà e i mercenari che stanno influendo potranno incidere sulle sorti del conflitto? E se comunque possono essere causa di ulteriori rischi…
Credo proprio di no. Lo renderanno più sanguinoso e anche di livello operativo più elevato. In caso di squilibrio di forze tattiche , si tende a passare a quello strategico e allora potranno essere impiegate armi di livello strategico come bombardieri, missili e perfino armi nucleari tattiche: tutte cose che porterebbero ad uno scontro diretto fra Nato e Russia.
Ritiene che il pericolo che i jihadisti-mercenari possano affluire dalla Siria in Ucraina in gran numero? E che complicanze si creerebbero nel conflitto?
I Jihadisti mercenari saranno pochi e potranno influire sul livello di barbarie, alzandolo. Di mercenari ce ne sono tanti e sono anche ben pagati. Quelli per l’Ucraina con i soldi nostri e quelli per la Russia con i soldi russi. L’afflusso di mercenari ha però un lato interessante: smonta completamente la tesi dei volontari combattenti per la patria. Inoltre, le compagnie di mercenari o contractors non si accontentano mai della semplice paga per i soldati ma pretendono sempre grandi cose dagli stati che li assoldano. Vogliono anche potere, assetti nazionali importanti come miniere, industrie, infrastrutture sensibili. Non sono mai soddisfatti e sono caduti dei regni per mercenari insoddisfatti.
Sui negoziati in Bielorussia. La Francia e Germania sembrano orientate ad un approccio di maggior mediazione mentre il nostro paese, assente nel vertice franco-tedesco-cinese, sembra preferire una visione più oltranzista. Giudica le richieste della Russia una base di partenza valida per l’Europa e cosa si rischia prolungando l’attesa di un vero confronto?
Le richieste russe, come in qualsiasi negoziato sono la base di una discussione. Se non è soddisfacente, ciascuna parte deve finirla di dire cosa vuole e cominciare a pensare cosa può cedere. In genere il più forte è quello più disponibile a cedere perché ritiene di “concedere” e quindi mantiene il prestigio intatto. La parte più debole deve solo ridimensionare il livello di ambizione. In questo caso ogni minima riduzione dell’ambizione ucraina porterebbe una grande concessione: la salvezza del paese. Il nostro paese ha decretato unilateralmente, come se parlasse per tutti, la fine dei negoziati, fra l’altro con un atteggiamento bullistico. L’atteggiamento degli altri è molto meno arrogante. E questo li rende in sintonia. Ma anche nel bullismo non siamo fra i migliori. La Gran Bretagna e la Polonia ci battono.
Il governo polacco ha dichiarato di voler fornire i propri Mig alle forze ucraine, ma facendoli partire dalle basi tedesche. Gli Stati Uniti hanno poi frenato l’iniziativa polacca. Quanto è reale l’opzione di una No fly zone in Ucraina e quanto è probabile un futuro coinvolgimento militare della NATO?
La dichiarazione di No fly zone dei cieli dell’Ucraina sarebbe un modo per accelerare il disastro. Chi la sta chiedendo a gran voce vuole il disastro e dimostra la propria incapacità di controllare il proprio spazio aereo. Vuole un pretesto per trascinare in guerra tutta l’Europa. Non dobbiamo cedere a questa tentazione perversa, soprattutto nei momenti come questi quando un attacco aereo finisce per colpire un padiglione di ospedale e l’emozione soffoca la razionalità.
La narrativa occidentale cerca oggi di minimizzare (o censurare del tutto) la presenza di neo-nazisti nei battaglioni incorporati alle forze ucraine, nonostante decine di reportage (dalla Bbc al Time al Guardian) in passato avessero fatto luce sulla vicenda con toni giustamente inorriditi. Ritiene credibile Putin quando parla di denazificare l’Ucraina come uno degli obiettivi?
La denazificazione a cui si riferisce Putin non riguarda l’Ucraina, ma il suo apparato governativo in cui tali elementi si trovano anche in posizione di vertice. I reportage hanno tutti ragione e comunque non rendono l’esatto conto della presenza e dell’influenza di questi gruppi. Sono state proprio le forze di polizia e dell’intelligence ucraina ad opporsi all’inserimento di tali elementi nei loro ranghi. Hanno dovuto subire ma oggi la caccia al russo (o filorusso) potrà mutare in caccia al nazi e visti i numeri e la frenesia degli interessati non mi stupirei se domani l’Ucraina cadesse dalla padella della guerra contro la Russia nella brace di una guerra civile .
Cosa dovrebbe fare il governo italiano in questo contesto e più in generale l’Europa?
Negoziare, finirla con il pensiero unico e la propaganda, aiutare l’Ucraina a ritrovare la ragione e la Russia ad uscire dal tunnel della sindrome da accerchiamento non con le chiacchiere ma con atti concreti. E quando la crisi sarà superata, sperando di essere ancora vivi, Italia ed Europa dovranno impegnarsi seriamente a conquistare quella autonomia, dignità e indipendenza strategica che garantisca la sicurezza europea a prescindere dagli interessi altrui.