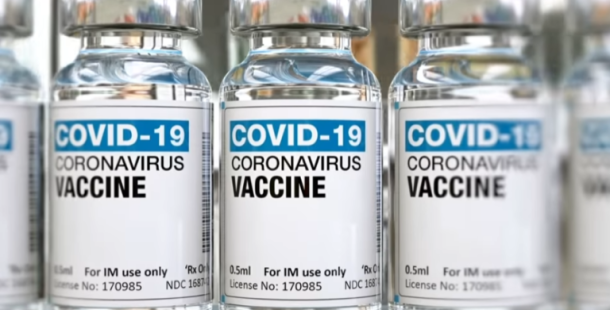Licenziamenti collettivi, un’alluvione senza argini
Gkn allo stabilimento di Campi Bisenzio, Whirlpool nello stabilimento di Napoli. Nel primo caso, 422 persone. Nel secondo, 356 persone. Licenziate con un tratto di penna, che nell’era della tecnologia cheap diventa un messaggio whatsapp, o una pec. Sono solo due esempi dell’alluvione che sta per allagare il tessuto sociale dopo la fine del blocco dei licenziamenti decretato a causa dell’epidemia di Covid-19. Un provvedimento tampone, seguito da un “avviso comune” Confcooperative, Cna, Confapi e Confindustria da una parte, sindacati dall’altra, con l’egida del Governo, che recita: le parti “si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua” . Raccomandazioni, nient’altro che raccomandazioni. Con le quali infatti alcune multinazionali si sono già spazzate il didietro, procedendo a comunicare i licenziamenti con modalità che ricordano le ferriere dell’800.
La debolezza ormai storica della rappresentanza politica di quella parte del mondo produttivo che è lavoro salariato si misura in tutta la sua profondità in questa fase di “ritorno alla normalità”, la peggiore per chi si ritrova senza tutele nel momento in cui il blocco dei licenziamenti termina: evento che produce lo stesso effetto di quando togli un tappo ad una falla senza che nel frattempo sia stato creato un recipiente in grado di contenere tutta l’acqua che uscirà.
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” Sembra una dichiarazione burlesca, calata dentro la situazione di fatto dell’industria italiana. Invece è il testo dell’art.41 della Costituzione. La legge che dovrebbe determinare “i programmi e i controlli opportuni perchè l’attività economica possa essere indirizzata a fini sociali” nel caso di specie è la disciplina sui licenziamenti collettivi, contenuta nella legge 223 del 1991, da coordinare con la legge Fornero e poi con il Jobs Act, che non hanno fatto che accentuare il suo carattere antisociale. Faccio un’affermazione così perentoria perchè la ratio che ispira questa disciplina è l’assunto secondo il quale è l’impresa stessa, in piena autonomia, a decidere quando uno “stato di crisi” giustifica l’apertura di una procedura di riduzione del personale. Non ci sono correttivi o interventi esterni all’impresa che possano realmente mettere in discussione la fondatezza delle ragioni della chiusura o della ristrutturazione, al punto che una multinazionale che complessivamente aumenta i profitti può permettersi di dichiarare la decisione di chiudere un “ramo secco” della propria produzione senza che alcuna regola o sanzione ne possa condizionare o scoraggiare la scelta. Le uniche regole imposte riguardano il rispetto di modi e tempi della procedura di discussione con la controparte sindacale: elementi formali, burocratici, il mancato rispetto dei quali tra l’altro non comporta nemmeno la reintegra di quei lavoratori illegittimamente selezionati per il licenziamento, ma solo una tutela indennitaria (nemmeno risarcitoria: quindi, un piatto di lenticchie). Per il resto, nella migliore delle ipotesi si finisce in mobilità, con un trattamento economico che dopo 24 mesi finisce. Per chi come il sottoscritto svolge attività sindacale, questa cornice legislativa è una palla al piede, che costringe a giocare costantemente di rimessa, a inseguire gli eventi senza poterne minimamente influenzare la genesi, potendo alfine solo negoziarne gli effetti su alcuni (da salvare) rispetto ad altri (da condannare). Come corollario arriva il disprezzo bipartisan per il ruolo del sindacato, chiamato a difendere i lavoratori con armi spuntate in partenza, che ne riducono la funzione a gestore del meno peggio. Come accennavo prima, questa situazione di cornice legislativa gravemente contrastante con il dettato costituzionale è il frutto di decenni di abbandono di una cultura politica che ha trasfuso il conflitto sociale e l’idea di uguaglianza sostanziale dentro leggi cardine come lo Statuto dei Lavoratori, che infatti è vecchia ormai di cinquant’anni. Questo abdicare alla propria funzione, che avrebbe dovuto essere un imprinting della propria stessa ragion d’essere, è una gravissima responsabilità della sinistra storica scagliata nel mondo globalizzato del post 1989, topos nel quale ha mostrato una inadeguatezza di aggiornamento ideale e di comprensione dei mutamenti tumultuosi dei fenomeni sociali che l’ha resa subalterna alle logiche economiche non tanto capitalistiche, ma liberistiche; con un cedimento al liberalismo che, applicato alla vita economica e sociale, produce effetti opposti rispetto al progredire del libertarismo nel campo dei diritti civili. Un liberismo, sia detto per inciso, che non esclude affatto l’intervento dello Stato nell’economia, purchè l’intervento serva a sovvenzionare le imprese con strumenti di sostegno (La Cassa Integrazione) completamente svincolati da qualunque reale impegno dell’impresa stessa in termini di investimenti per la riqualificazione degli impianti. L’impresa prende i soldi dallo Stato e quando decide di delocalizzare lo fa, e basta. Questo, in brutale sintesi, è il risultato della libera circolazione dei capitali. Questo, in brutale sintesi, è il frutto della “iniziativa economica privata” riguardo alla quale il legislatore ordinario degli ultimi trent’anni(di destra, di centro e di sinistra) si è ben guardato dal coniugare libertà e rispetto della dignità umana e sociale, con buona pace del dettato costituzionale.
Una soluzione a breve termine non c’è, in tasca non ce l’ha nemmeno Draghi, a prescindere dalla considerazione sul suo più o meno elevato tasso di keynesismo (sopravvalutato, a giudicare dalla scelta degli uomini in settori cardine della macchina economica dello Stato). Esiste solo la possibilità di perseguire, dentro una cornice asfittica, una serie di interventi di riqualificazione professionale che non possono, ovviamente, essere disgiunti da scelte di politica industriale che pianifichino attività di riconversione (pensiamo al settore dell’energia) prima che le decisioni di chiusura dispieghino i loro nefasti effetti sociali.

Sostieni periscopio!
Nicola Cavallini
PAESE REALE
di Piermaria Romani
Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.
Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.
(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)