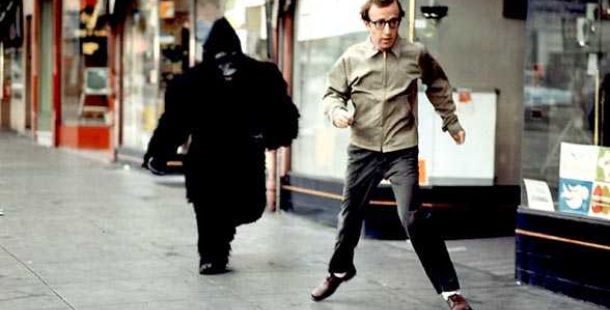La passione per le cattive notizie
E’ noto che le cattive notizie attraggono l’attenzione di più di quelle buone. Ogni giornalista lo sa: le cattive notizie aumentano le tirature dei quotidiani e alzano gli ascolti alla tv. Persino le previsioni di drammatiche nevicate a bassa quota, piogge torrenziali, freddo polare e così via (che tra qualche mese saranno rimpiazzate dalle previsioni sulla siccità) sembrano produrre un certo “godimento”. Si intuisce che in questi annunci non è in gioco il servizio, ma lo spettacolo della paura.
I telegiornali fanno quotidianamente simili operazioni, alzando la voce prima di tutto e creando un clima di emergenza, anche con il concitato incedere del discorso. L’apertura del Tg5 ne è un esempio, ma i talk show non sono da meno! Certo, mi si dirà, la situazione non è rasserenante e basta un po’ di maltempo perché si verifichino frane disastrose. Ma c’è anche altro.
Se mi interrogo sulle ragioni trovo molte risposte, nessuna da sola completamente convincente. Innanzitutto, paga l’attenzione per ciò che è sensazionale, fuori dalla norma, straordinario, si tratti di un fenomeno naturale, di un atto di follia umana, di una disgrazia imprevedibile. Inoltre, il dolore muove sentimenti di empatia e, in un certo senso, mette in prospettiva e ridimensiona le fatiche e i guai quotidiani.
La commozione per le disgrazie altrui ci fa sentire buoni a poco prezzo. È noto che i video diventano più facilmente virali quando suscitano commozione: si sa che siamo più solidali con il dolore altrui, in cui specchiamo una nostra eventuale sofferenza, che con la felicità dei nostri simili, che sollecita emozioni di invidia.
Gli eventi drammatici hanno un effetto simile a quello di un thriller: ci immergiamo nel film con emozione, avvertiamo realmente paura, come se fossimo dentro lo schermo, ma al termine della visione riusciamo a prendere le distanze e ci ritroviamo nella nostra realtà quotidiana, che a quel punto ci appare rassicurante e, persino, molto meno noiosa di quanto la pensassimo poco prima.
La paura è un’emozione che paralizza e lascia impietriti. È un’emozione ben diversa da quella correlata all’incertezza, alla difficoltà di valutare e prevedere le conseguenze di diversi corsi di azione. La paura, in un certo senso, ci deresponsabilizza. In un tempo in cui sentiamo crescere l’incertezza, la paura può diventare rassicurante, perché toglie la responsabilità di agire, di scegliere il corso di azione da intraprendere, nella vita privata come in quella pubblica.
La preferenza per le cattive notizie si declina su molti piani. Ad esempio, provate ad affermare che i tassi di criminalità comune sono in Italia molto inferiori a quelli di molti Paesi europei, provate a smentire, con dati alla mano, la convinzione che negli ultimi anni sia aumentata la criminalità diffusa; provate a dire a genitori di preadolescenti che la probabilità di stalking on line è di gran lunga più remota di quella che si verifica nella scuola o nei gruppi di pari; provate a dire agli insegnanti che non vi è alcuna ragione di avere paura che le tecnologie siano dannose per i minori, se loro stessi sono in grado di alimentare buone relazioni e capacità riflessiva. In tutti questi casi riceverete risposte ostili, in quanto contrarie ad una consolidata, quanto infondata, certezza.
La paura è una risposta pigra all’incertezza, una scorciatoia facile di fronte alla difficoltà di comprendere e fronteggiare le questioni del proprio tempo.
Maura Franchi (Sociologa, Università di Parma)
Laureata in Sociologia e in Scienze dell’Educazione. Vive tra Ferrara e Parma, dove insegna Sociologia dei Consumi, Marketing del prodotto tipico, Social Media Marketing e Web Storytelling. I principali temi di ricerca riguardano i mutamenti socio-culturali correlati alle reti sociali, le scelte e i comportamenti di consumo, le forme di comunicazione del brand.
maura.franchi@unipr.it