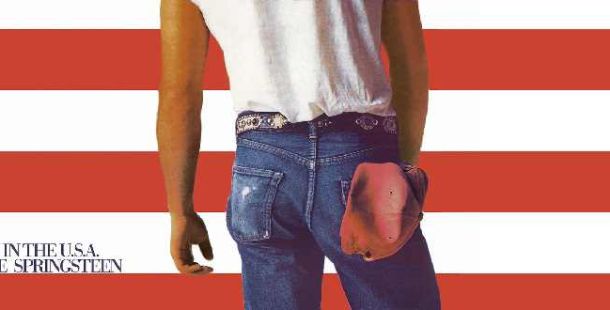LA MEMORIA
Osteggiati in vita, compianti da morti: l’ipocrisia nella lotta alla mafia
Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare (Giovanni Falcone)
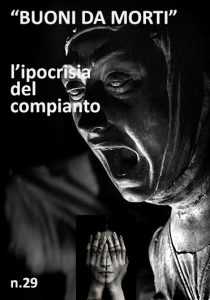 Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Sono i nomi più conosciuti, più celebrati, di quell’annus horribilis che fu il 1992: i due magistrati del pool di Palermo e gli agenti delle loro scorte. Padri, madri, figli e figlie, fratelli e sorelle, che hanno dato la propria carne e la propria vita – segnando inevitabilmente anche quella dei propri cari – per lo Stato e le Istituzioni.
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Sono i nomi più conosciuti, più celebrati, di quell’annus horribilis che fu il 1992: i due magistrati del pool di Palermo e gli agenti delle loro scorte. Padri, madri, figli e figlie, fratelli e sorelle, che hanno dato la propria carne e la propria vita – segnando inevitabilmente anche quella dei propri cari – per lo Stato e le Istituzioni.
Se ne fossero degni allora e se ne siano degni ora, anzi mi correggo, se ne fossimo degni e se ne siamo degni (perché in fondo lo hanno fatto anche per noi, i cittadini di questo Stato, anche se a volte sia lui sia noi ce ne dimentichiamo): beh questo è ancora tutto da vedere!
In questo venticinquesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via d’Amelio, un piccolo passo in avanti è stato fatto, per esempio, uscendo almeno in parte dalla stucchevole retorica. Quel Csm con il quale i rapporti sono sempre stati, per bocca dello stesso vice presidente Legnini, “difficili e conflittuali”, lunedì 22 maggio ha dedicato alla memoria di Giovanni Falcone un plenum straordinario presieduto dal Presidente della Repubblica, nel quale la sorella Maria ha lanciato un duro ‘j’accuse’: “non posso fare a meno di pensare alle sofferenze che quest’aula ha inflitto a Giovanni”, ha affermato scossa Maria Falcone, in particolare la bocciatura della sua candidatura alla guida dell’Ufficio istruzione di Palermo, da allora “Giovanni cominciò a morire”. Anche per questo forse il consiglio superiore della magistratura ha deciso di rendere consultabili i suoi atti che riguardano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.
E prima di intervenire martedì sera alla trasmissione di Fabio Fazio sulla rete ammiraglia nazionale, Roberto Saviano così ha scritto su Instagram: “L’Italia è il Paese felice in cui per essere credibili bisogna essere ammazzati, diceva Giovanni Falcone. A ogni commemorazione della strage di Capaci, non posso fare a meno di ricordare che solo sui cadaveri gli italiani riescono a esprimere una solidarietà e un’empatia disinteressate. Chi ricorda Falcone solo come un uomo amato e un magistrato apprezzato fa torto alla sua memoria. Falcone in vita è stato invidiato, odiato, criticato, diffamato e isolato. E una volta solo, è stato ammazzato”.
Lo Stato sa piangere i suoi morti, i funzionari, gli investigatori fedeli, bravi e sopravvissuti spesso finiscono con l’essere dimenticati, ancora prima dei morti. È quello che è successo a Rino Germanà, commissario e poi questore che quegli eventi li ha vissuti giorno per giorno e che nel settembre 1992 ha rischiato anche lui di essere un altro di quei nomi celebrati.
Entrato in polizia nel 1979, dal 1984 al 1987 è dirigente del commissariato di Mazara, poi diventa capo della Squadra mobile di Trapani, proprio nei giorni in cui Borsellino assume l’incarico di procuratore di Marsala. Lavorano insieme, in quegli anni, a tante indagini sugli intrecci fra organizzazione mafiosa, massoneria, politica, riciclaggio di denaro, individuano la matrice mafiosa dell’omicidio di Mauro Rostagno. Germanà arriva alla Criminalpol siciliana, ma quasi d’improvviso nel 1992 viene trasferito nuovamente a Mazara. E’ appena avvenuta la strage Falcone, Borsellino è già procuratore aggiunto a Palermo e vuole Germanà per le indagini antimafia del suo ufficio. Non si spiega quella retrocessione, che espone fra l’altro il commissario a gravi rischi. Non avrà il tempo di far pervenire la richiesta al Viminale: muore assassinato in luglio in via d’Amelio.
Alla Criminalpol, Rino Germanà si stava occupando di indagini su mafia e politica ed era spuntato fuori il nome del ministro Calogero Mannino.
Il 14 settembre sul lungo mare un commando di Cosa nostra tenta di farlo fuori a colpi di Kalashnikov, i killer sono nientemeno che Leoluca Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. Germanà risponde al fuoco, è ferito ma si salva. Secondo il pm Andrea Tarondo, che ha chiesto e ottenuto le condanne per mandanti ed esecutori di quell’agguato, una “manina” aveva scritto quel trasferimento quasi a portarlo a pochi metri dagli assassini più spietati di Cosa nostra.
Il ministro dell’Interno che lo accoglie a Roma dopo l’agguato è Nicola Mancino, sua la decisione di allontanarlo dalla Sicilia e dalle indagini che stava facendo. La nuova destinazione è: dirigente del commissariato di frontiera all’aeroporto di Bologna. “Per la sua sicurezza”.
Solo diversi anni dopo il Viminale si ricorda di lui: viene mandato alla Dia di Roma e poi nominato questore, prima a Forlì e poi a Piacenza, incarico con il quale è andato in pensione nel 2015. Per la medaglia d’oro al valor civile ha dovuto attendere 24 anni, gli è stata conferita, sicuramente non ‘concessa’, nel maggio 2016.
Martedì 23, invitato dal Presidio di Libera del Centopievese ‘Barbara, Giuseppe e Salvatore Asta’, ha incontrato a Cento i ragazzi delle scuole superiori e la cittadinanza.
“Non penso di essere stato bravo e che i miei colleghi lo fossero meno di me”, esordisce il commissario, “non ho scelto di fare il poliziotto per fare la lotta alla mafia. Fui chiamato ad Agrigento (la sua seconda sede di lavoro, ndr) non perché fossi bravo, ma perché non voleva andare nessun altro: non sapevo ancora nulla di polizia giudiziaria, ma mi ci sono messo con impegno e umiltà”. Proprio ad Agrigento “ho avuto la possibilità di conoscere il sistema mafioso, i mafiosi veri, quelli descritti da Sciascia ne Il giorno della civetta”. Con il suo racconto Germanà sembra voler scalfire appunto quel racconto retorico degli eroi irraggiungibili, quello che spesso serve da alibi per la nostra coscienza: non ha fatto il poliziotto per vocazione, “quello è affare da missionari”, “io facevo il poliziotto, facevo il mio dovere con impegno”, “nelle attività di polizia chi fa indagini per andare sulle prime pagine prima o poi ne verrà travolto”, l’importante è aver fatto sempre tutto il possibile, “non ho nulla da rimproverarmi”.
Parla però di conversione a proposito dei mafiosi, perché “noi – dice – siamo il bene”: “loro maneggiano la morte e non hanno memoria e non hanno rimorso”. Ed è sicuro, come lo era Falcone, che un giorno saranno sconfitti: “lo Stato è più forte”.
“Ho imparato a interrogare i mafiosi, a intervistare il nemico da Giuliano Guazzelli, un maresciallo ucciso ad Agrigento nel giorno del suo compleanno”, anche lui nel 1992: è un dialogo basato sulla continua ridefinizione di “un rapporto di forza”. Così Germanà ha interrogato il padre di Matteo Messina Denaro, anche lui boss, Pietro Rampulla, “che ha predisposto l’esplosivo per la strage di Capaci, una mente diabolica” e Gioacchino Calabrò, “che ha fornito l’auto per la strage di Pizzolungo”, quella nella quale sono morti proprio Barbara Asta e i suoi due gemelli nel 1985: “non vi voglio dire cosa ho visto quando sono giunto sul luogo dell’attentato”.
Ad Agrigento Germanà ha lavorato anche con Rosario Livatino, il giudice ucciso nel 1990 a 38 anni. Di Paolo Borsellino ha detto: “era una persona semplice, con un sorriso accattivante, di lui ho sempre avuto per lui un timore reverenziale. Lui aveva stima di me: me lo ha dimostrato il 4 luglio 1992 quando è venuto a Marsala, a fare il saluto ai colleghi da Procuratore uscente. Mi ha detto “Preparati, devi venire a Palermo con me”, era la prima volta che mi dava del tu”.