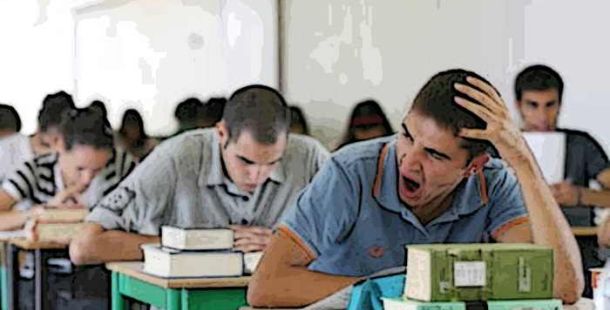LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA
È tempo di riprendere la strada
Tempo di lettura: 4 minuti
Il digital self-harm è l’autolesionismo digitale, il cyberbullismo che prevalentemente gli adolescenti praticano nei confronti di se stessi.
Ma questo bisogno di autodistruzione non è nuovo, tutta la nostra esistenza è uno scontro tra Eros e Thanatos, addirittura sacralizzato dalla nostra pratica di aderire ad una confessione religiosa.
Che poi l’odio per noi stessi si sia trasferito dalla sfera privata alla sfera digitale non c’è da meravigliarsi. I pensieri di odio che spesso si rivolgono agli altri in realtà rappresentano le cose che si temono dentro noi stessi. Gli atti di odio sono tentativi di distrarre se stessi da sentimenti come la solitudine, l’impotenza, l’ingiustizia, l’inadeguatezza e la vergogna. Può essere così che noi si divenga una minaccia a noi stessi.
Eros e Thanatos sono i portatori dei loro opposti, l’amore e la morte, la morte e la vita, così l’amore di sé può tradursi nella propria fine, mentre la propria fine nel proprio inizio.
L’intera drammaturgia della nostra vita interiore si riassume nell’essere o non essere dell’Amleto shakespeariano e, del resto, la vita dell’uomo su questa terra inizia con il mito cristiano dell’autodistruzione dell’uomo ad opera del peccato originale nel giardino dell’Eden.
Tutta questa premessa per dire che non sappiamo mai dove andiamo e che non abbiamo motivo di credere né in noi stessi né nella nostra bontà.
Sta di fatto che la presunta solitudine che viviamo innanzi ai nostri laptop disegna in rete con miliardi di like il profilo della nostra fragilità, quella fragilità che chiamiamo privacy, di cui pare che siamo gelosi, ma che ormai abbiamo globalmente resa pubblica, palese a tutto il mondo, lì a dipingere il ritratto dell’umanità che siamo.
I pensieri in rete non hanno bisogno di essere coerenti, è sufficiente che rispondano alle regole del post o del cinguettio, all’hashtag del momento. Sono le parole chiave che guidano i nostri pensieri, non il senso di responsabilità che pare essere ininfluente nel mondo virtuale.
Siamo tutti degli alias dietro ai nostri avatar e nickname che popolano la realtà aumentata, una sorta di autismo collettivo che ha invaso il mondo.
È pericoloso quando a questo autismo di massa pretendiamo di affidare le sorti della nostra democrazia, della storia e della convivenza di una comunità che non sa più guardarsi in faccia, che non è più in presenza, ma sempre assente e distante, che non fa più uso dei freni inibitori del coraggio di guardarsi negli occhi.
C’è un cervello collettivo digitale che sta prendendo lo spazio delle menti riflessive, un digital self-harm di massa, un cyberbullismo collettivo, comunitario, di una comunità interconnessa.
La “socialcrazia” sopravanza la democrazia derubricata tra i reperti dell’era prima di internet.
È l’epoca della socialcrazia, della rete che clicca e che vota, della rete che discute e delibera, dei parlamenti che si svuotano perché le politiche si decidono in rete non dai de-putati, ma dai “digital-putati”. Siamo la Social-Community, il Social-State, con la sua Social-Law e il suo Social-Civil Service.
Se lo shock del futuro era il timore di un’epoca di spersonalizzazione dei rapporti umani, che le nuove tecnologie ci avrebbero portati a perdere il senso di appartenenza alla comunità, allora ecco, il futuro è servito, il futuro è questo presente di grandiose architetture di autolesionismo digitale, di cyberbullismo prodotto dall’uso sconsiderato della rete.
La minaccia che abbiamo di fronte è la fragilità, l’assottigliamento dei vincoli sociali, contro il social autolesionismo, contro il social autismo sono i vincoli sociali con i loro obblighi che vanno recuperati, che hanno urgente necessità di essere ripristinati, di nuove manutenzioni. I social sono solo piazze virtuali che rischiano di annettersi le piazze reali.
Per questo siamo ostinatamente convinti che il nostro sia il tempo delle città. Che le città sono il cuore della nostra salvezza, della nostra democrazia. Che le città sono oggetti delicati, fragili, dove tornare a tutelare e nutrire le relazioni sociali, le virtù degli incontri e delle condivisioni.
Abbiamo bisogno di ritrovare la strada, non solo in senso figurato, soprattutto come luogo fisico, geografico, sociale e materiale. E la strada è nelle nostre città. La città come luogo in cui si ritorna fisicamente dall’esilio digitale per scoprire come è fatto l’altro, l’alias dell’avatar e del nickname in carne ed ossa. La città dove si torna a comunicare con le parole a voce e non scritte, dove lo scambio del dialogo avanza lo scambio dei post, la città dove mettere in piazza i nostri volti per tornare a riconoscerci senza gli hashtag. È il viaggio di ritorno che dobbiamo compiere dal virtuale al sociale.
in copertina illustrazione di Carlo Tassi