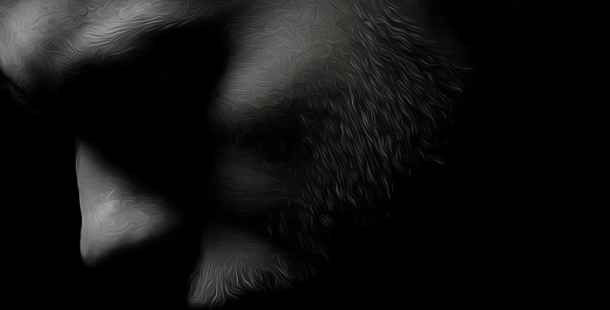Auschwitz, bimbi e selfie tra le camere a gas:
quando si banalizza la ‘banalità del male’
I ragazzi delle classi quarte dell’istituto Orio Vergani di Ferrara in viaggio nei campi di sterminio, a contatto con la tragedia della Shoah e le deviazioni del turismo di massa.
Partenza alle 5 della mattina di martedì 11 ottobre, ci attendono 15 ore di autobus. Per tutto il viaggio siamo accompagnati dalla pioggia e sul Tarvisio persino dalla neve. Attraverso Austria e Repubblica Ceca, arriviamo in serata a Cracovia. È la seconda volta che mi reco ad Auschwitz, in questa occasione sono insieme a quaranta studenti delle classi quarte dell’Iis Orio Vergani. Il viaggio della memoria, finanziato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, è la tappa conclusiva di un percorso di approfondimento sulla comunità ebraica cittadina: sono più di 100 i cittadini ferraresi di origine ebraica deportati prima nel campo di smistamento di Fossoli di Carpi e poi nei campi di sterminio nazisti, per la maggior parte ad Auschwitz. Di questi solamente cinque hanno fatto ritorno.
Giovedì 13 il programma prevede in mattinata la visita a Kazimierz, il quartiere ebraico di Cracovia, che ormai lo è solo di nome. Insieme ai ristoranti kosher e ai chioschetti per turisti, più che gli abitanti sono rimasti solo gli edifici delle sinagoghe e il cimitero ebraico rinascimentale meglio conservato d’Europa a testimoniare la ricchezza di quello che prima del 1939 era uno dei principali centri culturali dell’ebraismo ashkenazita. Anna, la nostra guida, ci fa vedere dall’esterno la fabbrica di Oscar Schindler e ci porta nelle strade lungo le quali Steven Spielberg ha girato il suo “Schindler’s List”, con tanto di immagini del film appese lungo le pareti esterne delle case per le eventuali foto ricordo. Un altro maestro del cinema, Roman Polanski, è cresciuto qui a Cracovia e ha vissuto nel suo ghetto: lui e suo padre sono riusciti a salvarsi, sua madre è morta proprio ad Auschwitz. Quando finalmente si è sentito pronto per girare un film sulla Shoah ha scelto però la storia del pianista di Varsavia Władysław Szpilman, inserendo solo alcuni frammenti della propria vicenda personale. Non ha potuto avvicinarsi di più a quel fondo di incomunicabilità che è insito nell’esperienza della Shoah.
Dopo aver camminato nei luoghi dove gli ebrei hanno vissuto per secoli, il pomeriggio è stato dedicato al campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau: Auschwitz I, il primo campo con gli edifici in mattoni, in origine caserme polacche e austriache, dal 1947 è museo nazionale, dal 1979 tutto il complesso, che comprende anche Auschwitz II-Birkenau e Auschwitz III-Monowitz (dove era internato Primo Levi), è sito Unesco.
Ricordavo il viavai dei pullman e i gruppi in attesa delle guide; la quantità e il vociare delle persone, l’odore del cibo di strada però mi sembrano aumentati rispetto alla volta scorsa, i gazebo con il metal detector e per le radio con auricolari, poi, sono una novità. Una volta entrati, noto che i ragazzi si fanno silenziosi e attenti, non usano più i loro smartphone se non per fotografare i viali, i block nei quali entriamo e il loro contenuto, ma facendo sempre attenzione a inquadrare solo i reperti nelle teche, le immagini e i pannelli alle pareti, o al massimo le nuche dei compagni davanti a loro.
Sono proprio i ragazzi a farmi notare, con un tono più di rimprovero che di stupore, alcuni turisti di origine asiatica davanti a quegli stessi blocchi impegnati in quello che sembra ormai il rito per eccellenza del turismo di massa e non solo: i selfie, con tanto di bastone, gambetta alzata e sorriso da personaggio di fumetti. Proseguendo la visita, lungo i corridoi rivestiti con le foto scattate agli internati poco dopo il loro arrivo e, in molti casi, poco prima della loro morte, noto che ci precede una mamma con un bambino di quattro o cinque anni al massimo. Lo rivediamo mentre attraversiamo in coda gli angusti spazi sotterranei del blocco della morte, quello con le prigioni del campo, il muro per le esecuzioni e la pertica di legno alla quale i detenuti venivano appesi per le mani legate dietro alla schiena. Si guarda intorno perplesso ed è difficile pensare che qualcuno gli abbia spiegato dove si trova, forse non è nemmeno auspicabile, se nel regolamento del museo stesso si sconsigliano le visite di minori al di sotto dei 14 anni. Poco più tardi, come farebbe qualsiasi bambino, corre lungo i viali alberati fra le palazzine di mattoni rossi, peccato che lì accanto ci sia la forca per le impiccagioni dei prigionieri che avevano tentato la fuga e poco più avanti la camera a gas con il crematorio del campo. In tutto ciò c’è qualcosa che stride fortemente perché Auschwitz I è sì un museo storico con una imprescindibile funzione memoriale e pedagogica, ma non è un museo storico come gli altri: è anche il luogo dove è stato perpetrato lo sterminio di 1 milione e 100.000 persone: 1 milione ebrei, 75.000 polacchi, più di 20.000 zingari, 15.000 prigionieri di guerra sovietici e oltre 10.000 di altre nazionalità.
Non sono certo questioni nuove, già nel 2014 sulla rete c’erano state polemiche per la pagina facebook aperta da una ragazza israeliana con selfie di ragazzi sorridenti in visita in vari campi polacchi (leggi qui). E questo è solo l’ultimo tassello dei problemi posti dalla costruzione della memoria e dalle pratiche memoriali, in particolare quelle sulla Shoah, con la scomparsa dei testimoni e nella nostra cultura dei media, ora anche virtuali.
È stato più volte osservato come si sia ormai arrivati a una monumentalizzazione della memoria della Shoah, che ha portato a sua volta un distacco e un distanziamento per cui possiamo ormai ipotizzare il passaggio dall’era della memoria a quella della commemorazione. Negli ultimi anni la memoria della Shoah si sarebbe cioè trasformata in ossessione commemorativa, dovere della memoria in senso retorico, con il conseguente passaggio dalla valorizzazione dei luoghi della commemorazione alla loro sacralizzazione e alla trasformazione dei siti storici in musei e mete per visite organizzate. Una possibile interpretazione di tali fenomeni è fornita da Andrea Minuz (espeto di cultura visuale e Shoah), che distingue fra ‘memoria della Shoah’ e una più ampia ‘cultura dell’Olocausto’.
Auschwitz è il luogo di due storie successive: quella dello sterminio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale e quella di un sito della memoria. A chi appartiene Auschwitz? A chi cerca di sviluppare un vasto piano pedagogico, con un archivio e un centro di documentazione e un museo in cui professionisti spieghino le diverse forme della criminalità nazista? Oppure appartiene a chi ne vuole fare un cimitero, il luogo in cui sono state sparse le ceneri delle vittime e in cui si deve venire solo per commemorarle? Seppure dolorose, queste discussioni sono inevitabili per mantenere in vita la memoria, per evitare che questa si trasformi in un rituale vuoto.
Il Museo di Auschwitz è assimilabile a uno di quelli che lo storico francese Pierre Nora ha chiamato ‘luoghi della memoria’, luoghi artificiali per i quali è necessaria un’apposita decisione affinché assumano il valore di luoghi del ricordo e della commemorazione, e contemporaneamente un ‘sito autentico’, luogo nel quale lo sterminio si è svolto.
Quello che molti visitatori ricordano maggiormente della visita al museo del campo sono i momenti di fronte alle teche di vetro con gli oggetti dei deportati e i capelli umani. Il rischio è che tali resti ci obblighino a ricordare le vittime attraverso lo sguardo dei loro carnefici, come questi ultimi avrebbero voluto che fossero ricordati: solo attraverso i resti di una cultura distrutta. Tali oggetti, il modello dei vagoni nei quali le vittime venivano deportate o quello della camera a gas di Birkenau, sono fantasmi della memoria, ci ricordano solo la morte: come se la memoria della vita delle comunità fosse persa per sempre. La teca con le due tonnellate di capelli mette in luce la contraddizione implicita nella conservazione dei siti dello sterminio: conservare i capelli significa preservare una prova del crimine, mentre sotterrarli significa preservare la dignità delle vittime. Per questo si è anche pensato di trovare una soluzione di compromesso ispirandosi ai monasteri francescani, che interravano i monaci in cripte dove il microclima assicurava una perfetta mummificazione naturale dei corpi: bisognava creare un luogo simile nel museo per sotterrare i capelli, facendo in modo che rimanessero nello stesso tempo visibili ai visitatori. Un problema simile è sorto nel caso dei crematori di Birkenau fatti saltare dai nazisti prima della partenza: restaurarli per mostrare come erano quando funzionavano o lasciarli come sono in quanto prova del crimine, ma anche del tentativo di cancellare il crimine stesso. Qui si è scelto di lasciare le macerie come erano e poco altro del sito è stato toccato. Ecco perché l’atmosfera è del tutto diversa: nei più di 170 ettari di Birkenau, dove furono stipate fino a 100.000 persone, sono rimaste solo poche baracche intatte, al posto delle tante bruciate e distrutte solo i camini e i contorni dei luoghi dove sorgevano, solo queste tracce per capirne il numero. Ma del resto la parola greca istoría, non significa ricerca, conoscenza attraverso l’indagine?
In un articolo apparso sul quotidiano “La Repubblica”, Salvatore Settis ha affermato che “la vera, la grande “redditività” del patrimonio culturale non è nella sua commercializzazione, e nemmeno nel turismo e nell’indotto che esso genera, bensì in quel profondo senso di identificazione, di appartenenza, di cittadinanza, che stimola la creatività delle generazioni presenti e future con la presenza e la memoria del passato”. Ciò vale a fortiori quando tale passato è la Shoah, quando cioè si vuole perpetuare la memoria di una sofferenza che per molti interpreti trova nel silenzio la risposta più profonda. In questo senso i luoghi della memoria dell’Olocausto corrono costantemente il rischio di essere percepiti, come è successo a Primo Levi quando è tornato ad Auschwitz nel 1965, come un insieme di cose morte facenti appello solo alla curiosità voyeuristica di coloro che li visitano, rimanendo però impotenti di fronte alla sclerotizzazione della memoria del genocidio degli ebrei ed alla sua trasformazione in narrazioni innocue in quanto prive del potenziale critico necessario.
La visita al complesso di Auschwitz-Birkenau, ai blocchi, alle baracche, alle camere a gas, il cammino lungo i binari delle selezioni fino ai resti dei crematori è un’esperienza e dunque va vissuta e interiorizzata: meno selfie e più riflessione, interpretazione, discussione, perché la memoria non sia un rituale vuoto, ma una pratica sociale da trasmettere di generazione in generazione.
Clicca sulle immagini per ingrandirle

Sostieni periscopio!
Federica Pezzoli
PAESE REALE
di Piermaria Romani
Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.
Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.
(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)