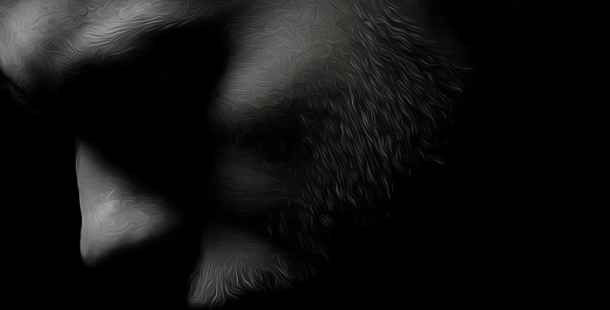Gianna corri
di Maurizio Olivari
Erano le 4 e 40 quando il suono insistente del telefono irruppe nel silenzio della notte. Quando qualcuno chiama a quell’ora, si pensa subito ad una disgrazia.
E proprio a questo pensava Gianna mentre rispondeva al telefono. Dall’altra parte era sua madre, con voce concitata le disse di andare all’ospedale, dove era stato ricoverato il padre. “Gianna corri” le disse prima di riattaccare.
La ragazza rimase impietrita, all’inizio non ci fu reazione: la cornetta del telefono in mano e lo sguardo nel vuoto per diversi minuti.
Doveva prendere una decisione: andare o restare lontana da quel mondo che aveva abbandonato, lasciandosi alle spalle i rancori della sua famiglia?
Mentre ci pensava, iniziò quasi come un automa a vestirsi, lo fece con calma, scegliendo gli indumenti con estrema cura, anche se poi decise di mettersi addosso una semplice tuta da ginnastica, un paio di scarpe sportive e uno zainetto.
Abitava a 30 kilometri dalla città, salì in macchina e si mise in viaggio. Sentiva le parole di sua madre ripeterle “Gianna corri“, se le sentiva in testa, forti e chiare, eppure guidava a bassa velocità… il tempo si era come fermato.
Pensava che avrebbe incontrato suo padre, erano passati tre anni dall’ultima volta, pensava a come sarebbe stato, si immaginava la scena.
Si erano lasciati in malo modo, con parole offensive, parole che lasciano il segno, che non si dimenticano.
Era figlia unica e aveva passato tutta la vita coccolata da tutti, soprattutto da suo padre che aveva sempre adorato. Ricordava ancora quel giorno della sua infanzia, quando gli aveva detto “Papà, quando diventerò grande, ti voglio sposare”.
Guidava lentamente, era buio ma le luci dell’alba sarebbero comparse a est di lì a poco. Aveva scelto la strada provinciale che attraversava un paese dietro l’altro, finchè vide un bar già aperto e si fermò. Entrò, ordinò un caffè e si sedette a un tavolino. Guardando all’esterno della vetrata, fu attratta dalla luce intermittente dell’insegna che rischiarava a tratti il buio che ancora resisteva all’avanzare del primo mattino.
Accesa, spenta, accesa, spenta… “Vado o non vado, vado o non vado…” Era pur sempre suo padre, anche se l’ultima frase che gli aveva detto andandosene di casa, era stata “Ti odio“.
Le incomprensioni erano nate con l’adolescenza: i primi morosi che suo padre mal digeriva, le richieste di poter uscire la sera con gli amici ripetutamente negate, le proibizioni a potersi vestire alla moda come le amiche e come piaceva ai ragazzi, i perentori divieti di fumare qualche sigaretta, di tingersi i capelli di rosso…
Suo padre era inflessibile, e questo la frustrava. Solo sua madre sembrava comprenderla, almeno un po’. Suo padre se lo sentiva sempre più distante, ostile, incomprensibilmente sordo ad ogni sua richiesta, anche se la madre la invitava a ragionare, ricordandole che lui non aveva mai smesso di adorarla e che se era severo era solo per il suo bene.
Un giorno si innamorò di una ragazzo un po’ fuori dalle righe, lo aveva trovato subito interessante proprio per quel suo essere diverso. Si vestiva in modo strano, ascoltava musica alternativa, si comportava come se non esistesse nessuna regola da seguire. Ma con lui Gianna si sentiva a proprio agio, lo trovava divertente e alla fine arrivò a considerarlo l’uomo della sua vita. Suo padre non reagì bene, considerò la scelta della figlia come l’ennesima bravata, l’ennesimo affronto. Ma anziché prendere la cosa di petto, la sua reazione fu quella di avere un atteggiamento sempre più distaccato. Per la prima volta sembrò disinteressarsi a quello che stava facendo la figlia.
Gianna avrebbe preferito una litigata, un confronto anche violento, anziché quell’indifferenza angosciante.
Ma tra i due la tensione massima fu raggiunta quando decise di lasciare la scuola, all’ultimo anno di Liceo Classico. Pensare che il liceo l’aveva scelto su pressione di suo padre, mentre lei avrebbe preferito l’Istituto Tecnico.
A questo si aggiunse la sua volontà di andare a vivere con il suo strano ragazzo, lasciando la famiglia. E proprio in quell’occasione, mentre sua madre piangeva disperata, suo padre non disse una parola, limitandosi a guardarla con disprezzo. Lei raccolse poche cose personali, e uscì di casa pronunciando appunto quella parola: “Ti odio”.
Tornò in macchina e ripartì, guidava piano rispettando i limiti di velocità, anche se a quell’ora non avrebbe incontrato nessuno a controllare. Aveva sempre in testa le parole di sua madre: “Gianna corri“. Ma lei non correva affatto, anzi, andava più piano del solito.
Avevano ricoverato suo padre d’urgenza, ma questo pareva non interessarle affatto. Da tre anni non aveva più un padre, quel padre che aveva tanto amato.
Poi arrivò all’ospedale, chiese informazioni e salì al piano del reparto. L’ascensore sembrava ancora più lento, i pensieri erano come congelati. Finalmente la porta si aprì e iniziò a percorrere il lungo corridoio fino alla stanza indicata. Fu lì che si accorse di quanto forte le battesse il cuore, e quasi faceva fatica a respirare. Era a pochi metri dalla stanza quando vide uscire una barella ricoperta da un telo bianco, sotto quel telo giaceva un corpo. Immediatamente dopo uscì sua madre che, vedendola, le andò incontro e disse “Sei arrivata tardi, tuo padre non c’è più. L’ultima parola che ha detto è stata Gianna… e tu non c’eri.“
Sua madre si allontanò senza aggiungere altro, non un saluto, non un abbraccio. Era una donna annientata, distrutta dal dolore, ma la lasciò senza nessun’altra parola, se ne andò e basta. Eppure era sua madre.
Gianna entrò nella stanza vuota, si sedette accanto al letto che aveva ancora l’impronta di suo padre, poi appoggiò il capo sul cuscino, come se volesse sentirne di nuovo la presenza, il calore. Avrebbe voluto piangere ma dagli occhi non uscì nemmeno una lacrima, solo un vortice di pensieri che le si accavallavano nella testa. Furono i ricordi ad affiorare da quel caos mentale: momenti della sua infanzia, attimi di gioia vissuti con suo padre. La bambina che giocava al teatro coi burattini insieme al suo grande “papi”, quello che allora era il suo eroe, il suo tutto, l’isola felice che la faceva sentire protetta e coccolata. Sentiva che cantavano le sigle dei cartoni animati della televisione. Si rivedeva nelle corse nel parco, nelle nuotate in piscina, poi alle bellissime feste di compleanno, o a Natale, quando lui si travestiva tutto di rosso e si metteva quella buffa barba bianca che lo faceva starnutire, credendo che lei non lo riconoscesse, e le portava i doni. E lei che, per non deluderlo, fingeva di stupirsi e di credere che quel signore così impacciato e con quella voce così familiare fosse veramente Babbo Natale.
Poco dopo un infermiere entrò nella stanza, le consegnò alcuni documenti del padre dimenticati dalla mamma, poi le chiese se poteva lasciare la stanza perché doveva sistemarla per un altro paziente in arrivo. Tra quelle carte trovò una busta di plastica con la tessera sanitaria e una piccola fotografia di suo padre con lei caricata sulle spalle, entrambi sorridenti e felici. L’avvicinò alle labbra e la baciò.
Tornando a casa pigiò a fondo sull’acceleratore, questa volta voleva far presto, aveva fretta di tornare a casa. Forse per arrivare in un luogo sicuro dove sentirsi protetta, e difendersi da quella fragilità improvvisa che le era piombata addosso, da quell’insicurezza che non aveva mai avuto prima. Ad attenderla c’era il suo giovane compagno, quello che aveva causato la rottura con suo padre. E lui non ebbe nemmeno una parola di consolazione, anzi, disse una cosa che non avrebbe mai dovuto dire: “Non si meritava altro“
Gianna non disse niente, lo guardò e forse lo vide per la prima volta, poi raccolse le sue cose in una valigia e uscendo gli sussurrò “Ti odio“.
Si fece ospitare da un’amica, con l’intenzione di tornare da sua madre, sempre che l’avesse accolta volentieri. Però non si decideva mai a chiederle di ritornare, forse era pudore, vergogna, rimorso, non sapeva. In fondo quella era stata la casa della sua infanzia.
Lentamente, ogni giorno che passava si consumava, come una candela accesa troppo a lungo. Non aveva appetito, non dormiva, in breve tempo era dimagrita in modo eccessivo. Soffriva e non si curava. Aveva sempre in testa quella frase: “Gianna corri” e lei non l’aveva fatto, era arrivata tardi.
Per questo non si dava pace, non era riuscita a prendere la mano di suo padre, a stringerla al petto e dirgli “Ti voglio bene“. A chidergli perdono, ad abbracciarlo ancora una volta, l’ultima. Non era riuscita a fare niente di tutto questo.
Poi era arrivato il giorno di Natale, e Gianna decise di trascorrerlo da suo padre, al cimitero. Portò un fiore, una rosa rossa che tanto gli piaceva, e lo sistemò assieme agli altri fiori in parte già appassiti, nel vaso poggiato sulla tomba in marmo bianco. Suo padre la osservava dalla foto al centro della lapide, in quella foto sorrideva, come era solito fare tutte le volte che era stato con lei, prima del loro distacco.
Guardò a lungo quel sorriso, s’inginocchiò e disse “Papà sono qui, sono tornata“. Per la prima volta si sentì serena, in pace, ma era molto stanca e si sdraiò sulla tomba, dove finalmente trovò la forza di piangere.
All’ora di chiusura, un guardiano del cimitero, mentre faceva il consueto giro per controllare che non ci fosse più nessuno, vide che la ragazza che si era sdraiata sulla tomba del padre era ancora lì. Si avvicinò, “Signorina, dobbiamo chiudere” le disse, ma lei non rispondeva. Le prese una mano per aiutarla ad alzarsi, ma la mano era gelida, rigida come il resto del corpo.
No, non era per l’aria fredda del Natale, semplicemente ora Gianna era con suo padre.

Sostieni periscopio!
Redazione di Periscopio
I commenti sono chiusi.