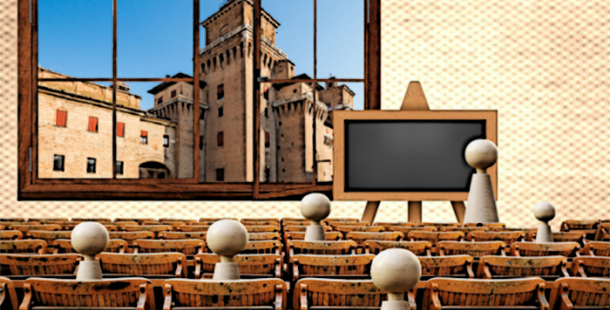EMENDAMENTO DELOCALIZZAZIONI:
Cronaca di una morte (del lavoro) annunciata
Lo ha detto anche Matteo Renzi, durante uno dei suoi adoranti endorsement al principe saudita Bin Salman: “sono invidioso del vostro costo del lavoro”.
A leggere i dati, l’invidia dovrebbe riguardare soprattutto il costo – e quindi lo stipendio – dei lavoratori non sauditi in Arabia, molto più basso della paga media degli “indigeni”. Ad ogni modo, la logica è quella: vi invidio perché potete permettervi di pagare poco i vostri lavoratori.
Meraviglioso, non trovate? Eppure l’amico dei califfi rinascimentali Matteo (mi limito a definirlo così, senza ulteriormente indugiare sul tipo di califfi da cui si fa pagare) dovrebbe accontentarsi. In fondo, l’Italia è l’unico paese dell’area Euro in cui le paghe sono arretrate in valore reale negli ultimi 20 anni, rispetto agli altri paesi (Germania, Francia, Spagna, Grecia…) in cui invece sono aumentate, in misura maggiore o minore.
Secondo alcuni economisti, più che all’elevata incidenza dei contributi, la dinamica depressiva salariale sarebbe da correlare alla scarsa produttività del lavoro in Italia. Un modo semplice per spiegare il concetto di produttività del lavoro è dividere i ricavi di un’azienda per il numero dei suoi addetti. Se il risultato è basso, non dipende dal fatto che in Italia i lavoratori sono dei fannulloni e altrove degli stakanovisti, ma dalla combinazione dei fattori della produzione: numero degli addetti, prezzi di vendita, grado di automazione. In una parola, dall’organizzazione dei fattori di produzione, tra cui il lavoro delle persone.
L’organizzazione dei fattori di produzione è nelle mani di chi governa le aziende. Siccome la nostra dinamica salariale è già abbastanza depressa, per aumentare la produttività del lavoro occorrerebbe agire non sull’abbassamento dei salari, ma sull’innovazione dei processi e dei prodotti. Purtroppo, la maggior parte delle imprese italiane sono piccole aziende piuttosto allergiche all’innovazione, all’utilizzo delle tecnologie digitali, alla formazione del personale. Sto chiaramente generalizzando, ma i dati mi autorizzano a farlo: molte imprese italiane sono piccole, impiegano un capitale modesto e sono governate da persone con la testa rivolta all’indietro.
Questo pistolotto serve (anche) per comprendere a chi è destinato l’emendamento alla legge di bilancio con il quale il Governo dichiara di voler combattere, o almeno disincentivare, il fenomeno delle delocalizzazioni.
Fenomeno che possiamo esemplificare così: una mattina il Cda o l’AD di turno si svegliano, e indipendentemente dal fatto che l’azienda o il ramo italiano di quell’azienda sia in crisi, decidono di chiuderlo, e di licenziare i dipendenti. Per poi riaprire in un luogo dove la manodopera costa meno e rompe meno i coglioni.
Può bastare anche una dichiarazione di ristrutturazione aziendale per far sparire centinaia di posti di lavoro. Tutto il resto previsto dalla legislazione attuale è una semplice procedimentalizzazione della “crisi”, che passa attraverso il rispetto formale di tempi e modi di gestione della vertenza, che si può concludere comunque con la conferma unilaterale dei provvedimenti d’impresa. Non parliamo delle cessioni di ramo d’azienda, in cui gli unici deputati dalla legge a stabilire il “perimetro” dei lavoratori ceduti e non ceduti e gli eventuali esuberi sono il cedente ed il cessionario.
I lavoratori si attaccano al tram e tirano.
Questa è la cornice, di arbitrio legalizzato (non mi viene da chiamarlo altrimenti), nella quale ci troviamo.
In tale cornice si inserisce questo emendamento, che anzitutto presenta una singolarità: pare riferirsi solo alle imprese che occupano più di 250 dipendenti. Chissà quante saranno, uno pensa. Un estratto del censimento Istat delle Imprese 2019 (qui) lo chiarisce: ” i due terzi delle imprese (821 mila, pari al 79,5% del totale) sono microimprese (con 3-9 addetti in organico), 187 mila (pari al 18,2%) sono di piccole dimensioni (10-49 addetti), mentre le medie (con 50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) rappresentano il 2,3% delle imprese osservate (24 mila unità), di cui 3mila grandi.“
Se perimetriamo le aziende con più di 250 dipendenti, quindi, non arriviamo allo 0,5% delle aziende italiane. Mi auguro almeno che il numero di addetti sia riferito al totale degli stabilimenti facenti capo allo stesso marchio, altrimenti i padroni destinatari di queste norme non sarebbero pochi, sarebbero un numero quasi impercettibile. E’ poi evidente che il peso occupazionale di questo numero di imprese aumenta, perché sono poche ma occupano (dato del 2018) il 28,3% degli addetti. In ogni caso, fuori dalle nuove regole resterebbe comunque il restante 72 per cento circa dei lavoratori, e se si può comprendere per le microimprese, faccio fatica a concepire l’esclusione per le medie, che occupano fino a 249 addetti.
Ma veniamo al merito delle novità che dovrebbero fungere da deterrente al “chiudi, scappa e apri da un’altra parte”.
Intanto, non c’è nessuna sottrazione del potere unilaterale di una impresa di dichiarare uno stato di crisi o una necessità di ristrutturazione con taglio di posti, anche se i numeri di bilancio dicono che non sussiste alcuna crisi (ricordate la Logista che trasportava i tabacchi in area Interporto Bologna? Ricordate la Gkn di Campi Bisenzio? sono solo due esempi).
Viene confermata la logica “io so’ io e voi non siete un cazzo”, traduzione brutale ma efficace del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica.
L’articolo della Costituzione proseguirebbe con: “(l’attività economica)…non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, ma queste sono dichiarazioni di intenti buone per un Angelus di papa Francesco, mica devono tradursi in leggi a tutela di chi lavora.
Quello che cambia è la “sanzione” nel caso in cui l’azienda non adempia a qualche regoletta: la mancata presentazione di un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, entro sessanta giorni dalla comunicazione alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Anpal.
Senza presentazione del piano o se il piano non contiene gli elementi essenziali che lo qualifichino come “rilancio”, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo alla disoccupazione del lavoratore in misura pari al doppio. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo aumentato del 50 per cento.
Tradotto in schei, vuol dire dover pagare un massimo di 3.000 (tremila) euro per ogni lavoratore licenziato, ogni mese per gli ultimi tre anni. Postilla: se l’impresa in precedenza ha ricevuto sovvenzioni statali, non le deve nemmeno restituire.
Più che un deterrente, somiglia ad una stima di rischio aziendale. Se posso calcolare in anticipo la spesa massima che dovrei sostenere (se mi comporto proprio male) per chiudere e tagliare posti, si tratta della trasposizione su base collettiva della logica individuale del Jobs Act: ti licenzio illegittimamente? Non importa, tanto so prima di licenziarti quanto mi costa il tuo licenziamento.
Il capo di Confindustria Carlo Bonomi farà finta di lamentarsi, ma questa è una vittoria per il suo modo di concepire le relazioni industriali.
Il ministro del Lavoro e quello dello Sviluppo Economico hanno raggiunto un non-compromesso, e la cosa contiene una traccia di feroce verità: tutela del lavoro e sviluppo economico sono considerati temi antitetici.
Il che equivale ad ammettere che il conflitto di classe esiste.
Peccato che da anni stravincono sempre i più forti.