DIARIO IN PUBBLICO
Arroganza, superbia, umiltà
Al popolo degli ‘Itagliani’ evidentemente manca una preparazione almeno di base sul significato delle parole. Si prenda l’aggettivo ‘umile’, il suo avverbio ‘umilmente’ e lo si riporti al sostantivo ‘umiltà’.
Recita il dizionario:
“Umiltà è la prerogativa dell’umile. Nonostante esistano diversi modi di intendere questo termine nel quotidiano, una persona umile è essenzialmente una persona modesta e priva di superbia, che non si ritiene migliore o più importante degli altri.”
Così sostanzialmente s’intende il termine ed esso è tra le parole più significative nella letteratura. Basti ricordare “Vergine madre figlia del tuo figlio,| Umile e alta più che creatura” (Par.XXXIII), o l’atteggiamento di Laura nella glorificazione della sua qualità angelicata, “et ella si sedea | umìle in tanta gloria” ( Petrarca, “Chiare, fresche e dolci acque”).
Nella giornata dei premi Oscar sento e vedo le entusiastiche lodi rivolte al nostro Ennio Morricone. Franco Nero, commentando l’opera del musicista, sostiene che tutti i veri grandi sono umili, mentre un giovane attore italiano spiega che per lui comincia l’avventura hollywoodiana e che vi entra “umilmente”. Niente di meno esatto.
Se è spiegabile l’uso e l’abuso del termine nell’ambito dello spettacolo, esso è particolarmente pernicioso, per esempio, nel mondo della politica dove i nostri attori-politici scambiano la pretesa umiltà di cui s’ammantano con il termine contrario: l’arroganza, che non è la superbia, ma una sua pericolosa devianza. Certe esitazioni nella voce, il sorriso benigno ma calcolato, con l’occhio freddo e intento a nascondere pur senza riuscirci l’arroganza.
L’arroganza può essere anche esibita e ha una sua strepitosa valenza che affascina. Si pensi a Donald Trump, ma anche a tanti uomini politici in tutti gli schieramenti, da destra a sinistra, che popolano il Parlamento e il Senato italiani. Il perfetto arrogante che tenta invano di nascondersi dietro l’umiltà a mio parere è sicuramente Casaleggio, ma la scelta è varia e ricca la raccolta.
Tra le persone che esercitano l’umiltà in vera coscienza e consapevolezza, il più convincente è il medico lampedusano Pietro Bartolo che, nonostante l’assedio dei media e la sua entusiastica partecipazione agli show televisivi – inclusa anche la sua generosa compartecipazione alla riuscita di “Fuocammare”, il bellissimo film di Gianfranco Rosi – riesce a trasmetterci un’idea di umiltà che si fonda sulla superbia “buona” comprovata dal mestiere che fa. Dire umilmente che ha visto, protetto e curato in questi anni, da quando esercita la sua professione a Lampedusa, 250.000 immigrati sputati da condizioni intollerabili nel mare nostrum è una consapevolezza che trova la sua ragione in una forma di superbia altissima, corrispondente alla altrettanto, se non maggiore, constatazione che il concetto di bontà non può essere conosciuto se non nel rapporto con il suo contrario: il male.
Dante sicuramente è l’esempio più alto di superbia-umiltà in piena consapevolezza.
Ben differente la condizione dell’arroganza, che è il tratto più odioso di una mal concepita superbia. Lo sapeva Manzoni, che sul concetto di superbia e umiltà ha creato la figura nobilissima di Fra’ Cristoforo e su quello dell’arroganza il mediocrissimo Don Rodrigo.
L’arrogante, ripeto, tenta di nascondere questa prerogativa sotto l’aspetto dell’umiltà, ma anche sotto quello della superbia. Perfino nell’apparenza sociale l’arroganza viene spacciata per virtù. Ancora una volta ripropongo il mondo della moda come esempio antropologico della supremazia dell’arroganza per guadagnare consenso. Mai come quest’anno le modelle sono, per scelta del business della moda, brutte e indossano brutti vestiti. Eppure il loro atteggiamento, il loro incedere è qualificato dall’arroganza e dalla sfida di chi ha il mondo “in gran dispitto”. E ancor più preoccupante è l’atteggiamento altrettanto minaccioso dei loro colleghi maschi.
Quasi un rifiuto della bellezza, secondo l’ormai consolidata prassi che vuole la bellezza inutile. Apparenza obsoleta e non verità.
I branchi degli umani di cui sono ormai popolate le nostre città si travestono spesso secondo un concetto del brutto che rimanda purtroppo a quello di bruto (e la differenza non sta solo nella “t” in meno). Violenza e arroganza negano antropologicamente l’umiltà, ma anche la superbia.
Un’affascinante indagine sul concetto di umiltà è quella straordinariamente sollecitante di un romanziere le cui opere hanno letteralmente invaso il mondo, Javier Cercas, autore di grandi romanzi quali “Soldati di Salamina” o lo splendido “Anatomia di un istante”, ambientato storicamente al tempo del tentativo di colpo di stato che il colonnello Tejero nel 1981 cercò di effettuare entrando armato nel Parlamento di Madrid.
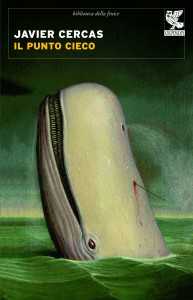
Cercas viene invitato a Oxford a tenere una serie di lezioni sul romanzo e sugli scrittori nel 2014. Il Prologo di quelle lezioni si concretizzerà in quella teoria che chiamerà “Il punto cieco”.
L’autore dubita che proprio a lui sia capitato in sorte di occupare la cattedra che fu di George Steiner, Mario Vargas Llosa, Umberto Eco, ma agisce come se non fosse stato colpa di “uno scherzo o di un errore”. Cercas difende la teoria che gli scrittori possano essere non solo critici di se stessi, ma debbano condividere con il lettore la possibilità che i romanzi, certi romanzi, quasi tutti ambientati nel XX secolo, obbediscano alla teoria del “punto cieco”.
Premette lo scrittore: “Io cerco di praticare l’umiltà, ma faccio in modo di evitare il masochismo, così tranne che nei brutti momenti, non mi considero uno scrittore tra i tanti” (p.16). Da ciò nasce una possibilità di conciliare la narrativa con la critica, il lavoro compiuto con la critica di quel lavoro. Proposte eseguite con umiltà come riconosce all’inizio, ma un’umiltà che è consapevolezza e integrazione della buona superbia. La teoria del romanzo a cui Cercas si riferisce implica una cecità parte dall’anatomia dell’occhio ipotizzata già nel Seicento dal fisico Edme Mariotte. Secondo questa teoria “i nostri occhi hanno un punto cieco, un luogo – sfuggente, laterale e non facilmente localizzabile – situato nella retina, che è privo di recettori per la luce e attraverso il quale, perciò, non si vede nulla”, ma “il sistema visivo riempie il vuoto del punto cieco con l’informazione disponibile perché il cervello supplisce a ciò che l’occhio non vede.” (p.20)
Il buio e il silenzio stimolati dall’intelletto diventano eloquenti. E questo è il senso dello scrivere romanzi al principio dei quali c’è una domanda e quello che vi si svolge è un tentativo di risposta a quella domanda. Alla fine però la risposta non c’è. Anzi, la “risposta è la ricerca stessa della ricerca”. Mai univoca, bensì aperta a molteplici soluzioni.
Ci si potrebbe chiedere cosa centra la teoria del “punto cieco” con l’umiltà, la superbia e l’arroganza. Credo che sia un modo efficace per capire come il romanzo, o qualsiasi forma d’arte, esprima una modalità di chiarire ciò che il mondo o noi stessi ci poniamo come necessario presupposto non solo di una qualsiasi domanda, ma di tutte le domande, le cui risposte staranno esattamente nel capirne la complessità e la molteplicità. Quasi un circolo che produce nient’altro che ulteriori domande, sempre più complesse, sempre più molteplici.
Così la cecità della presunzione, dell’arroganza del sapere, si chiarisce nel “punto cieco” che ci chiede invece di essere mai arroganti, ma superbamente umili.

















