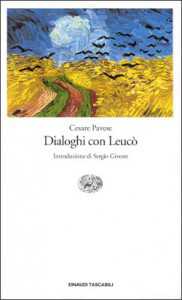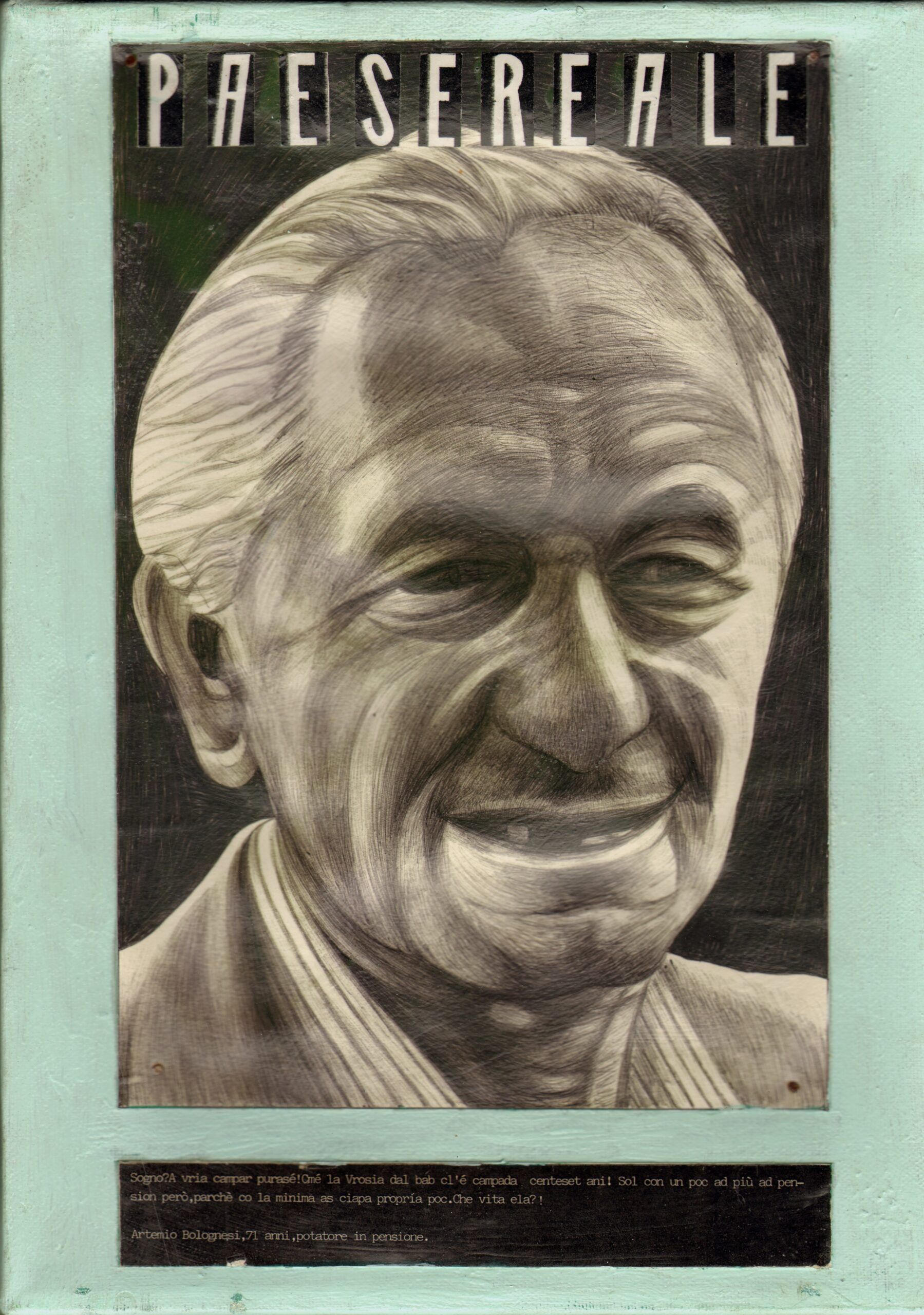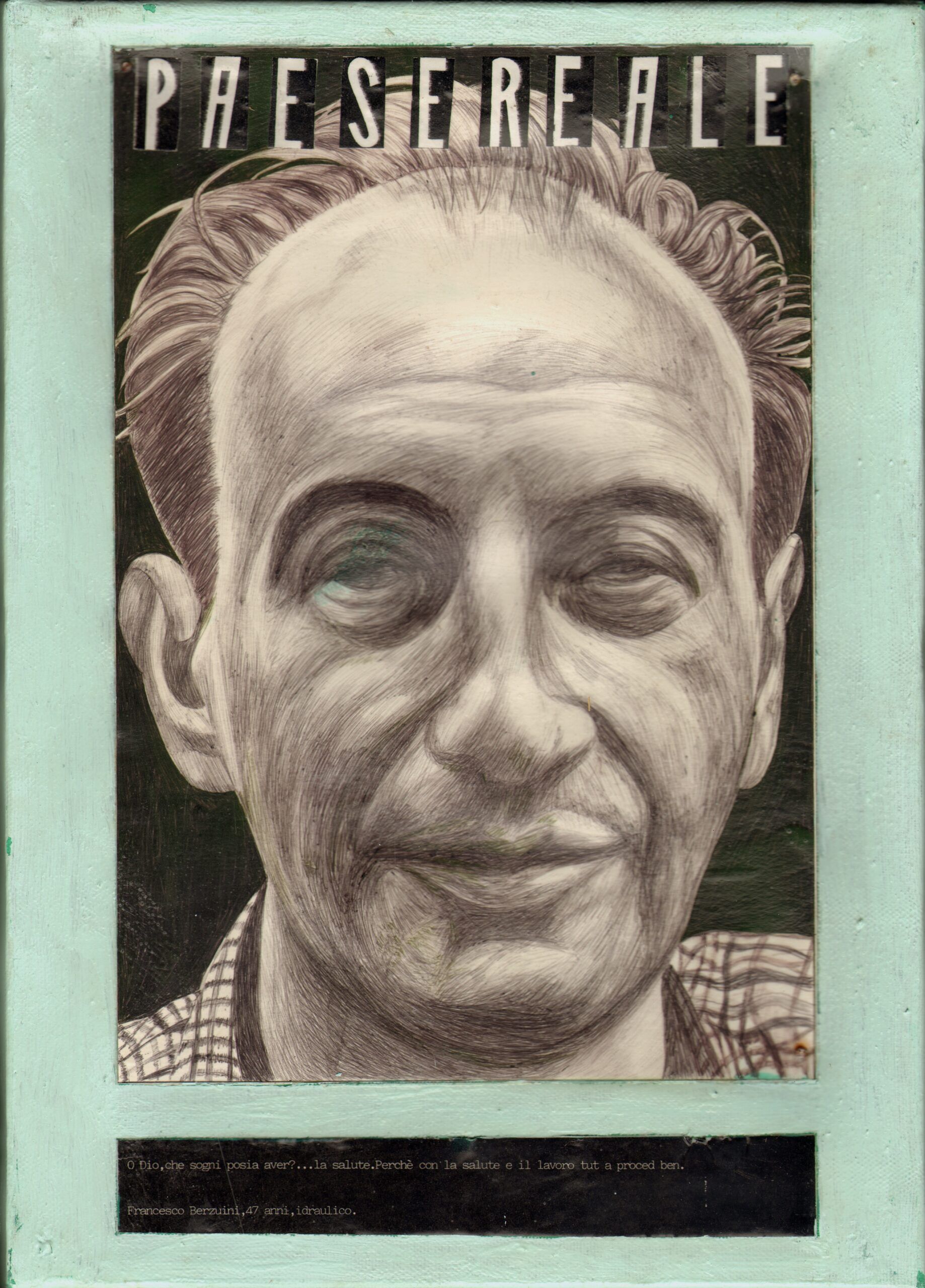LA RIFLESSIONE
Spiegare il destino ai giovani attraverso l’arte
Tempo di lettura: 4 minuti
Sono le sei di mattina del 5 maggio. Mi trascino fuor dal letto e spiego i vestiti della festa. Meno male che le abluzioni eran state fatte in stato di tranche a mezzanotte dopo il concerto dell’immenso Grigory Sokolov. Il gigante buono appare sul palcoscenico del Comunale con il suo viso triste, le spalle ingobbite, il frak strapazzato. Le luci debolissime a fatica illuminano i suoi capelli bianchi e si riflettono sul bordo del coperchio del pianoforte e la sala scandalosamente non esaurita ancora spiegazza carte di caramelle, stronfia nei fazzoletti, scatarra educatamente. Poi una piccola mano si alza e s’appoggia come una farfalla sui tasti. La prima nota del preludio della Partita di Bach impone un silenzio irreale e le Muse scendono lievi a consolare il cuore. Nella Sonata n. 7 di Beethoven quando s’inizia il Largo e mesto capisci che il paradiso non è solo gioia ma ripiegamento interiore che sommuove, direbbe Dante, il lago del cor. E tutti, anche gli scatarranti, si rendono conto che quel momento può e deve essere la felicità suprema. Non un gesto d’esultanza tradisce il mago: il viso rimane triste, le spalle s’insaccano ancor più, le gambe tozze s’avviano a fatica verso l’uscita e mentre scatta un urlo scomposto di gioia e di riconoscenza, reso ancor più sonoro dai battimani e dal ritmico pestar dei piedi, ti trovi a mormorare tra te e te: “Era già l’ora che volge il disio /ai navicanti e ‘ntenerisce il core/lo dì c’han detto ai dolci amici addio/e che lo novo peregrin d’amore/punge, s’e’ ode squilla di lontano/che paia il giorno pianger che si more.” Il resto è pura gioia. Schubert trascorre nel secondo tempo con quell’indicazione del primo movimento della Sonata op. 143 che recita Allegro giusto e si conclude con Allegro vivace e ancora ancora i sei Momenti musicali di cui tre sono Allegro e Allegretto. La sala invoca un bis e lui ne concede sei mentre le mani s’arrestano, ripigliano, volano, esitano e vibrano. Che felicità.
Poi, il giorno dopo, partenza per Milano. Ai giovani della Statale devo andare a raccontare del libro che mi danna e mi commuove da cinquant’anni: i “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese e dir loro cosa significa rappresentare il destino come esperienza e esigenza etica. Il viaggio si compie nell’irreale silenzio di chi dorme o di chi accudisce al suo bisogno di touch e di selfie mentre mi danno a capire o a tentar di capire perché il divino non può essere tale se non si mescola con l’umano. Poi alzo l’occhio dal libro e mi si presenta una Turandot in bianco anziché in nero. Chi legge forse ha visto il copricapo della perfida regina nell’allestimento Expo della Scala: un intreccio di veli, lustrini e boccoli o meglio treccine che si muovono lentamente e a volte convulsamente quando chiede di torturare Liù. La ragazza ha treccine che altro non sono che i fili che le penzolano dalle orecchie: bianchi come l’acconciatura dove tra i lunghi capelli s’intravvede il luogo a cui sono indirizzati, proprio nelle piccole orecchie che ricevono suoni lontani a cui come in trance la bianca Turandot risponde sussurrando dentro un piccolo scatolino pur bianco emettendo soffi di voce e brevi risatine amorose. E ti guarda la giovine, ma non ti vede come non ti vedono i milioni di persone che fanno svolazzare l’indice per avere una conoscenza che altro non si rivela che buio. Buio della conoscenza, buio nella condizione esistenziale.
Sbarco in una Centrale presidiata da discrete forze dell’ordine. Il taxista mi guarda disperato allorché gli comunico dove devo andare. “E’ tutto bloccato”, sussurra, ma dignitosamente tenta vie traverse e mi conduce dopo mezz’ora di peregrinazioni davanti all’austera facciata della Università meneghina. Tento di spiegargli che preferirei che i giovani, che mi si dice siano accorsi numerosi a sentire dalla voce di un grande poeta cos’è il destino – e di che destino si parla -, andassero in corteo a manifestare contro la “buona scuola”, ma sono folgorato dalla risposta che proprio loro mi daranno. “Qui sta a lei dimostrare se abbiamo fatto bene a scegliere di ascoltarla invece di andare in corteo”.

Capisco allora la responsabilità che hanno la mia generazione e quella successiva rispetto al destino di questi giovani e non posso che rispondere con quello che Pavese ha scritto. Il destino e la sua accettazione sta nel rendersi conto di ciò che l’uomo ha sperato e di ciò che ha patito. E tutto questo non può che attuarsi solo sfiorando quel manniano pozzo del passato la cui profondità è insondabile. Ma accostarvisi è il compito dell’umano e della sua ricerca etica.
Che almeno una briciola di questa ricerca tocchi la mente di chi fa politica. Lo vogliono questi giovani e con loro Croce, Gobetti, Einaudi, Salvemini, Gramsci e Matteotti, De Gasperi e Moro, Berlinguer e…
Alla fine i ragazzi eran soddisfatti e m’invitano a mangiar una pizza. Non sanno che io odio la pizza, ma questa volta l’ho mangiata di gusto e pure mi è piaciuta.
Copertine delle ultime edizioni Einaudi

Sostieni periscopio!
Gianni Venturi
Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it