Questo articolo vuole riportare in italiano le parti salienti dell’intervista (in inglese) visibile qui sul canale Youtube di Pressenza IPA https://www.youtube.com/watch?v=Aq13zCoRqU4 e ascoltabile come podcast qui https://podcasters.spotify.com/pod/show/imaginaction
Grazie a Daniela Bezzi per l’aiuto nella trascrizione e traduzione e a Fulvio Faro per il montaggio del video.
Di seguito riporto gli elementi che hanno attirato maggiormente la mia attenzione e che evidentemente si sono ancorati al mio vissuto, alle mie premesse, alla mia professione, e non da meno alle mie speranze.
Il cammino doppio e intrecciato di Combatants for Peace. Chen Alon più di una volta, nell’intervista, ha sottolineato come accanto al processo di riumanizzazione, training all’empatia e promozione del dialogo, ci sia la lotta congiunta, nonviolenta e creativa contro l’occupazione militare israeliana e il sistema oppressivo di apartheid. Ho trovato significativo che questo aspetto fosse sottolineato da Chen, israeliano, che dice: “Non ignoriamo la realtà dell’occupazione”. Senza questa affermazione così forte, la promozione del dialogo tra i due popoli potrebbe essere inficiata e accusata di “normalizzazione” (tatbya in arabo), ossia di normalizzare i rapporti come se non esistesse un sistema oppressivo e ingiusto. In questo caso, direi che le relazioni tra “nemici” più che “normalizzare” lo status quo, lo sfidano facendosi portatori di una realtà altra, per molt3 quasi inimmaginabile, e lo fanno insieme.
Aprire la mente. La pluralità di narrazioni. Sulaiman Khatib spesso fa riferimento alle narrazioni diverse e al ruolo che giocano nel mantenere il ciclo di violenza e nel rimanere bloccati nella storia dei propri traumi, così come all’opportunità che si apre quando si fa spazio alla narrazione dell’altro. Sulaiman racconta come la curiosità verso la storia degli israeliani abbia fatto parte della sua storia di trasformazione personale; accenna al fatto che la guerra di queste settimane è raccontata in due modi completamente diversi dai media israeliani e palestinesi (“siamo soliti dire qui che viviamo in film diversi”).Aprire il cuore. Avere spazio per il dolore dell’altro, del “nemico”. Sulaiman racconta di quando ha fatto spazio alla sofferenza per l’olocausto, Chen racconta che ora, dopo 18 anni di allenamento del muscolo dell’empatia, il suo cuore si spezza allo stesso modo per i bambin3 isrealian3 e palestines3 quando sono uccis3, rapit3, torturat3. In effetti, siamo addestrat3 a provare empatia solo per i nostri cari, i nostri vicini, i nostri “più simili a noi”. “(voglio invitarvi a) dare una possibilità all’empatia e all’umanità…” (Sulaiman).
Aprire la volontà. L’immaginazione come capacità fondamentale nella trasformazione del conflitto. Dice Chen: “una delle prime manifestazioni dell’oppressione è che la gente non riesce a immaginare un’altra realtà”. Sulaiman dice che la The Joint Memorial Ceremony, in cui israeliani e palestinesi sono in lutto insieme, chiedendo la fine della violenza, è in qualche modo qualcosa di inimmaginabile. Avere la capacità di immaginare l’inimmaginabile apre le porte davvero alla risoluzione creativa dei conflitti.
Il ruolo della comunità internazionale. Andare oltre le polarizzazioni e l’odio. In questo momento di forte polarizzazione, che alimenta da un lato l’islamofobia e dall’altro l’antisemitismo, Chen invita a essere spett-attori, ma non per tifare una o l’altra parte, ma chiedendosi “dov’è il palcoscenico in cui le persone stanno co-resistendo, co-esistendo, lottando insieme, riumanizzandosi a vicenda”. Sulaiman apprezza il risveglio della comunità internazionale, ma sente di distanziarsi dagli slogan che portano odio, invita a sintonizzarsi sulla vibrazione della vita.
E ora lascio la parola a Chen e Sulaiman, riportando stralci di gran parte dell’intervista.
La mia prima domanda è stata proprio su Combatants for Peace (Combattenti per la Pace), cos’e’ e cosa rappresenta nella loro vita oggi, in questa situazione così drammatica.
Sulaiman:
Combatants for Peace è nato durante la Seconda Intifada, da una conversazione che si teneva segretamente a Betlemme, tra alcuni palestinesi che stavano combattendo o erano in prigione, come me, e israeliani che erano stati nell’esercito. E dunque in breve, entrambi i gruppi sono giunti alla conclusione che non esiste una soluzione militare per la nostra causa, e che per alcuni di noi non esiste più un “noi” o un “loro”.
Come ho detto io stesso, sono stato in carcere per più di dieci anni dall’età di 14 anni, come tutti i miei amici adolescenti, mi sono trovato in varie situazioni per esplorare ciò che può funzionare. Ed è successo che alcuni di noi, se così posso dire, si sono avvicinati ai valori della nonviolenza e dell’umanizzazione dell’altra parte e abbiamo lavorato insieme per un futuro migliore, per i nostri popoli, sia palestinesi che israeliani.
(…) Credo che “Combatants For Peace” abbia contribuito molto ai movimenti di base a livello locale e globale che dimostrano che la trasformazione e il cambiamento sono possibili, e che trasformare quello che chiamiamo “l’altro” in un fratello è possibile e questo cambiamento non è eccezionale, solo per poche persone. Credo che ogni essere umano sia in grado di cambiare. Come dice Nelson Mandela, “le persone non odiano per natura, quando nascono, devono imparare a farlo…”. E quindi possono anche imparare l’amore e persino il perdono.
“Combatants For Peace” esiste da 18 anni. E l’identità principale, come ho detto dai fondatori, è quella di ex combattenti di entrambe le parti che lavorano insieme. E questo, per quanto ne so, è uno dei pochi modelli storicamente riconosciuti e che continuano a lavorare sul conflitto, con l’obiettivo di unire le forze per lavorare insieme a questa possibilità di riconciliazione storica, per la liberazione e la libertà dei nostri popoli da entrambe le parti.
Chen:
(…)
Io sono stato per più di 10 anni nell’esercito, sono diventato maggiore nell’esercito israeliano e ho avuto la stessa urgenza di Suli di proteggere il suo popolo. Anch’io ritenevo di proteggere il mio popolo. Credevo che la violenza, la resistenza, la lotta armata, la difesa, comunque la vogliamo chiamare, fosse la soluzione e poi ho capito che la violenza è sempre il problema e non la soluzione e ho deciso di rifiutarmi di svolgere il servizio militare per l’occupazione e per questo sono stato condannato e andato in prigione.
(…)
Anch’io, come ex combattente, come ex ufficiale, ho trovato i partner in un gruppo di persone, persone coraggiose nel fronte palestinese, che hanno abbandonato la violenza come mezzo di liberazione o mezzo di resistenza, di lotta.
Abbiamo quindi unito le forze per porre fine all’occupazione e all’apartheid insieme, e per sviluppare una comunità nonviolenta bi-nazionale. Dopo 18 anni stiamo definendo una cultura nonviolenta bi-nazionale. Stiamo sviluppando un’alternativa alla realtà come comunità, in modo che le persone possano unirsi a noi e far parte di questo giusto e paritario sistema di governo, anche utopico, nella nostra comunità che non ignora il contesto dell’occupazione e dell’apartheid, ma fornisce una realtà alternativa per le persone che resistono alla violenza, al ciclo di violenza e alla struttura di potere oppressiva.
E vorrei aggiungere, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, che cos’è “Combatants For Peace” oggi? Per me, e so che è lo stesso per Sulai, perché ho imparato questo termine da Sulai, noi siamo risoluti, fermi. Siamo una roccia ferma (…) nell’occhio di una tempesta di folle, orribile violenza, brutalità, barbarici attacchi che vanno da entrambe le parti, uccidendo persone innocenti e bambini. E noi stiamo incarnando la visione di stare insieme nella realtà, all’interno dell’occhio del ciclone. Per segnalare alla gente che saremo presenti anche dopo la fine della guerra e che saremo il seme attorno al quale si costruirà la prossima realtà, come comunità bi-nazionale, nonviolenta, pacifica, sensibile alla giustizia e ai diritti umani.
Invito Chen e Sulaiman, che hanno già un po’ anticipato le loro storie personali, a raccontare episodi della loro vita che hanno portato a un cambiamento di prospettiva e alla scelta della nonviolenza.
Chen:
(…) Intuitivamente, abbiamo iniziato il viaggio dei “Combattenti per la pace” sulla base dei principi dei Comitati per la Verità e la Riconciliazione in Sudafrica. Ciò significa che quando si racconta la propria storia personale attraverso la violenza, ci si assume la responsabilità della verità e della riconciliazione. Non significa che qualcuno deve perdonarti (…). Si tratta di un’azione di racconto della propria storia personale, di condivisione della propria verità e del proprio ruolo. A volte di testimone, a volte ruolo attivo nella realtà come persona violenta, come essere umano violento che ha disumanizzato l’altro fino al punto di essere disposto a uccidere, e in alcuni casi a uccidere davvero, altri esseri umani. Quindi, per essere onesti, non c’è un momento del genere, un unico momento di rivelazione o epifania che posso descrivere come IL momento della mia trasformazione.
Io sono un regista teatrale. Un creatore di teatro nel teatro. Un attivista e un artista. Quindi leggo la mia storia e leggo questi episodi che ho vissuto, attraverso un punto di vista teatrale, e cercherò di spiegare questo punto con alcuni esempi, uno dei quali è che ero già un attore di teatro e stavo interpretando un ruolo in uno spettacolo teatrale chiamato “Awake and sing” di Clifford Odets. È una commedia americana sulla Depressione del 1929 e io interpretavo il tipico giovanotto di famiglia. E tutta la famiglia è devastata dalla depressione economica. E come in una catarsi io alla fine dell’opera dico loro: “Non dipende da noi affrontare il nostro singolo problema, dobbiamo cambiare il sistema, il sistema di capitale dell’economia statunitense è il problema e dobbiamo cambiarlo, e questo creerà il cambiamento.” E a quel punto il pubblico applaudiva e beh, io indossavo un abito a tre pezzi con la cravatta nel Bronx degli anni ’30 o alla fine degli anni ’20 negli Stati Uniti a New York. E il pubblico era fuori di testa dinnanzi a questo giovane uomo rivoluzionario che indica una soluzione al problema sociale, economico e politico.
Mi sono tolto il costume di scena, sono salito in macchina e ho guidato per 45 minuti fino alla Striscia di Gaza. Era credo l’anno 1997, o 1996. Ho indossato la mia uniforme con il grado di maggiore ed eccomi comandante di un posto di blocco. Fermavo e bloccavo le famiglie palestinesi che volevano attraversare questo posto di blocco e dicevo: “Avete bisogno di un permesso per andare all’ospedale, avete bisogno di un permesso per questo e quello…”. E ricordo in particolare una giovane coppia con un bambino che cercava di attraversare questo checkpoint e così, eccomi lì la sera stessa, sul palco come giovane rivoluzionario che crede nel cambiamento sistematico del sistema e invoca una rivoluzione del sistema per portare giustizia e uguaglianza. E un’ora dopo sto recitando un altro ruolo, con la mia uniforme di oppressore, come comandante di un posto di blocco che non permette alle persone di passare. E dunque questo scontro tra questi due personaggi dentro di me, il modo in cui non riuscivo a integrare questi due ruoli, questi due personaggi (…) Mi sono detto: devi scegliere uno dei due. O sei un cittadino, un artista che invoca il cambiamento, ed è disposto a pagarne il prezzo. Oppure sei un ufficiale di una dittatura militare che controlla e domina milioni di persone. Non puoi essere entrambe le cose. E il prezzo da pagare è quello di essere un traditore del tuo popolo, essere considerato un traditore, sbattuto in prigione, ed essere boicottato e bandito dalla tua stessa gente.
E avrei altri esempi, se vuoi più avanti, mi limiterò solo a un altro, quello di aver impedito ai bambini di andare in ospedale, cinque anni più tardi, nella vicina Betlemme, mentre avevo cura di mia figlia, della mia bambina che andava all’asilo, nello stesso momento. Da una parte eccomi a dire: “Non potete andare all’ospedale, voi bambini in macchina (…); e allo stesso tempo chiamare mia madre per chiederle di andare a prendere mia figlia all’asilo perché la mia compagna quel giorno non poteva.
Quindi, di nuovo, questo concetto teatrale, di un personaggio, di ruoli nella vita, nella vita reale, e non essere in grado di integrare l’essere umano che sei, con altri ruoli sociali che ti trovi ad avere, stava arrivando a un punto tale che era troppo per me e mi sono rifiutato. Ero disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di impegnarmi nel ruolo di essere umano che non opprime altri esseri umani.
Sulaiman:
(…) come ho detto prima, sono stato in prigione quando avevo 14 anni. In realtà sono stato attratto dall’idea della rivoluzione, l’intreccio di Che Guevara, la kefia… e poi, durante il periodo di detenzione, quando ero in carcere, a 15 anni, mi sono unito in alcune occasioni ad altri prigionieri per uno sciopero della fame. E con questi due scioperi della fame, che sono durati circa 17 giorni, a volte 10 giorni, al fine di migliorare la vita quotidiana del carcere, abbiamo sempre avuto successo, in effetti. Questa è stata la mia esperienza pratica.
(…)
Sapete tutti che Mandela quando era in prigione ha letto della lotta nonviolenta e di altre parti del mondo, per esempio in India, e la storia di Martin Luther King e altri. Ma anche nella nostra cultura, direi anche nel contesto religioso spirituale, dalle nostre parti, c’è parecchio sul principio della nonviolenza, sulla cultura della tolleranza, “tasamuh”. (…)
Per me, quindi, quando parliamo di cambiamento verso la nonviolenza, non si tratta solo di una teoria del cambiamento o di un’ideologia o di una conversazione intellettuale, ma di andare molto più in profondità al cuore, all’anima e credo che sia importante, ed è così che io sono, essere veramente e pienamente in verità con noi stessi, non solo come intellettuale.
(…) io vengo da una famiglia che pratica la “riconciliazione” e questo si collega a tutta la cultura mediterranea del Medio Oriente con il processo di riconciliazione tribale, in cui ci sono sempre due lati della storia, o più di due lati (…). Ed è importante, io provengo dalla tipica famiglia palestinese, molto legata alla narrazione della causa palestinese, alla sofferenza palestinese, alla lotta palestinese, al desiderio di libertà. (…) Quando mi guardo indietro, penso che in parte, come ho detto, questo proviene anche dall’appartenere a una famiglia che riunisce insieme parti (gruppi) differenti nel sistema tribale e penso che una parte importante della mia missione di vita sia superare le differenze.
E dunque ero molto curioso e anche aperto a leggere anche la narrazione degli israeliani, se non altro per saperne di più, perché se mi predispongo ad aprirmi un po’ di più, significa che posso rinunciare un po’ alla mia (narrazione). Per esempio se provo empatia per la sofferenza del popolo ebraico, rispetto all’Olocausto, o prima, o dopo, si modifica anche il mio punto di vista di giustizia, o circa la mia causa come palestinese, e nel corso del tempo arrivo a un luogo in cui sento che questi termini o sentimenti non sono in conflitto, in cui possa permettere al mio cuore di percepire la legittimità di entrambe i popoli, di essere qui con tutto il dolore e il trauma… E capire che sono in grado, che noi siamo in grado… (…) di avere un cuore bi-nazionale e credo che questa sia la strada, con le nostre relazioni personali, con la nostra apertura.
Non perché siamo ingenui e non stiamo facendo nulla, ma perché è proprio così. (…) Ovunque, non riguarda solo la nostra causa. Credo purtroppo che la voce della violenza sia molto più forte, ma credo davvero che la maggioranza delle persone vorrebbe abbandonare questa cosa, per il loro bisogno di sopravvivenza e per le loro anime, smetterla di odiarsi e uccidersi a vicenda.
Chiedo a Chen e Sulaiman in che modo Combatants for Peace costruisce la fiducia e coltiva la riconciliazione, quali sono gli strumenti e le metodologie.
Chen:
Mi stavo unendo a “Combatants For Peace”, stavo co-fondando “Combatants For Peace” come un ebreo israeliano molto protettivo, nel senso che stavo proteggendo la mia identità(…). Stavo mettendo a fuoco, ed ero molto possessivo, riguardo la mia storia, il mio dolore, all’Olocausto, alla sofferenza, l’esilio, il bisogno di rifugio da parte della gente. E non so se si tratta di un training emotivo, empatico o spirituale che stiamo facendo in “Combatants for Peace”. Ma dopo 18 anni, posso dire che i bambini del Sud (Israele) e i bambini di Gaza mi spezzano il cuore allo stesso modo, quando vengono uccisi o rapiti o torturati. Quindi ora ho lo stesso posto nel mio cuore per i bambini quando sono uccisi, rapiti o torturati. Ho lo stesso posto nel mio cuore ed è facile perché ho dei figli, quindi è facile per me. Sento che è facile ora, ma non era così anni fa. E penso che quando parlo di training, non si tratta solo di esercitarsi all’empatia (…) Penso che sia il modo in cui ci stiamo allenando all’azione, che siamo impegnati in entrambe le pratiche e in entrambe le strade, entrambi i percorsi di “Combattenti per la Pace”.
Uno è il dialogo costante per la riconciliazione e la riumanizzazione. (…) per esempio, una delle pratiche è The Joint Memorial Ceremony, che abbiamo iniziato 18 anni fa con decine di persone in un teatro francese a Tel Aviv. Alle ultime quattro o cinque cerimonie che abbiamo fatto, la cerimonia annuale israelo-palestinese, hanno partecipato 15.000 persone in un parco a Tel Aviv con altre 200.000 persone online, che sentono l’esigenza di questo dolore comune, di questa agonia, di questo dolore da sentire insieme. E non è solo, come hai detto, un’esigenza israelo-palestinese, è un’esigenza internazionale. È un’esigenza umana di cui siamo testimoni in tutto il mondo. Questo è uno degli impegni che ci permette di sviluppare questi muscoli dell’empatia che stiamo allenando.
Ma ce n’è un altro (perché) il dialogo, la riconciliazione, la coesistenza e così via non sono sufficienti quando c’è un sistema sistematico così brutale e dominante di relazioni di potere che è oppressivo, cioè l’occupazione e l’apartheid. Quindi l’altro impegno, l’altro viaggio, l’altro percorso, l’altra strada che stiamo sviluppando oltre alla riconciliazione e alla riumanizzazione, è la lotta nonviolenta, la resistenza, il confronto concreto con il sistema oppressivo.
In questo modo, in vari modi, come azioni dirette, dimostrazioni, teatro d’immagine, teatro forum, manifestazioni, marce e vari modi di essere fermi di fronte all’oppressione insieme, israeliani e palestinesi sono schierati nello stesso movimento, la stessa azione, la stessa attività di fronte all’occupazione.
E penso che l’intreccio di questi due percorsi sia qualcosa di straordinario e unico per questo movimento bi-nazionale, che permette agli esseri umani impegnati nel movimento di avere, dopo anni e anni, un cuore bi-nazionale, e persino una mente bi-nazionale.
Sulaiman:
In “Combattenti per la Pace” e nella cerchia più ampia dei gruppi di attivisti ci sono molti strumenti. Hai menzionato lo strumento del storytelling; noi usiamo molte altre strategie e strumenti per aprirci a (..) una nuova narrazione che emerga, che nasca e non rimanga bloccata nella vecchia storia. E questo non è facile perché la gente è traumatizzata e più facilmente bloccata nella narrazione del vittimismo, perché c’è molto dolore e sofferenza in questo momento e in generale.
The Joint Memorial Ceremony (…) per umanizzare l’altra parte, è davvero al di là di ogni immaginazione. Il fatto di essere insieme nel dolore e nella solidarietà. Anche la cerimonia della Nakba è iniziata da quasi cinque anni. Camminare in collaborazione tra i nostri partner palestinesi e israeliani, per toccare un evento traumatico per i palestinesi e riconoscere quegli eventi che sono stati catastrofici nel ’48 per i palestinesi, è molto educativo, crea delle aperture e permette di non sottrarci di fronte agli argomenti più scabrosi, per entrare davvero in una conversazione difficile. E anche per costruire la fiducia e tutti i tipi di azioni nonviolente sul terreno. (…)
Per permettere alla gente di immaginare che questo posto può essere diverso, che non dobbiamo essere nemici per sempre, né combattere per sempre. (…)
Ho proposto a Chen e Sulaiman di immaginare, per Chen, di parlare con un bambino palestinese a Gaza, e per Sulaiman, di parlare con un bambino israeliano proveniente da uno dei kibbutz attaccati il 7 ottobre. Abbiamo fatto un momento di silenzio, per immaginare che, in qualche modo, ci siano le premesse che permettano a questi bambini di ascoltare con cuore e mente aperti. Hanno risposto con autenticità e delicatezza.
Chen
Devo dire, prima di iniziare, ho bisogno di un disclaimer e so che è una manifestazione dell’oppressione di cui sto soffrendo, perché questo è davvero impegnativo. (…) Una delle prime manifestazioni dell’oppressione è che la gente non riesce a immaginare un’altra realtà. La gente non riesce a immaginare un incontro utopico come quello che ci stai offrendo, e mi rendo conto che fa parte dell’oppressione il fatto che io non posso immaginare. È difficile per me. Perché non riesco a immaginare me stesso di fronte a un bambino palestinese a Gaza, mentre ascolta un uomo adulto ex soldato, ex ufficiale dell’esercito israeliano.
Quindi la mia prima immaginazione è andata in due direzioni ed è interessante perché prima di tutto vorrei chiederti di permettermi di portare Sulai, con me, per incontrare questo bambino palestinese… ho bisogno di Sulai per quell’incontro.
E l’altro pensiero che ho avuto è che non dirò nulla a questo bambino. Gli dirò che la mia prima responsabilità e obbligo è ascoltarlo. Per chiedergli cosa ha lui da dirmi.
(…)
Sulaiman
(…) Quando hai fatto la domanda, sono andato dentro il mio cuore per poter vedere (…) dei bambini israeliani. (…) Sì, sento che il mio cuore è molto pesante e anche in colpa perché una parte del nostro popolo ha rapito… Moralmente mi sento “triggerato”.(…) e provo anche una profonda e calda empatia per questi bambini che sono appena nati lì, che non hanno alcuna responsabilità indipendentemente da quale famiglia o in quale parte del mondo sono nati. E sono consapevole che questi bambini portano con sé anche i traumi delle loro famiglie. E quando sento questo, sento la mia parte di cuore salvatrice. Una parte di me si muove, vorrebbe salvare, vorrebbe proteggere. Vorrei dire a tutti questi bambini che sono protetti, che sono al sicuro e che sono amati. E mi dispiace anche per loro, perché noi adulti non siamo riusciti a impedire ciò che è successo il 7 ottobre, dopo il 7 ottobre, prima del 7 ottobre. Per tutti i bambini. Israeliani e palestinesi.
(…) E sento anche una grande responsabilità di continuare a fare quello che facciamo e anche di più per cambiare il corso di questa storia. E in questa missione, ci credo in pieno (…)
E sento che questi bambini sono stati usati per qualcosa che non hanno creato loro. E questo mi porta a (…) condannare, davvero, l’azione di rapire dei bambini, arrestare dei bambini, attaccare dei bambini, uccidere dei bambini.
(…) a quale livello di disumanizzazione siamo per arrivare a questo…
(…) Quando ho sentito il telegiornale e quando hanno parlato di bambini che sono stati rapiti tutti insieme, non sono riuscito ad avere alcuna immaginazione. Onestamente non riesco a immaginare perché non sono in grado di dare una spiegazione a me stesso, alla mia coscienza. Perciò chiamo davvero le nostre madri e le loro preghiere e (…) tutte le persone che hanno gli strumenti culturali per connettersi con la loro coscienza superiore e costruire questa nuova consapevolezza che possano davvero vedere e sentire di dare protezione a tutti questi bambini (…)
E ancor più sento che voglio lavorare, perché questo non accada mai più, si spera. (…)
(Voglio) mantenere il mio cuore aperto alla realtà collettiva, a tutta la realtà e cerco di mantenere un equilibrio con il sogno che questo posto possa diventare… (…) questo luogo possa diventare un modello di libertà globale. (…)
Chen
E dunque ora puoi capire, Ilaria, perché ho detto che porterò Sulai con me… (…) direi che io ho fallito, voglio dire, riconoscerò che abbiamo fallito nella nostra responsabilità, nella mia. Ho fallito nella responsabilità per questi bambini di Gaza, per te, bambino di Gaza, per quello che hai dovuto affrontare. L’unica cosa che gli chiederei, a questo bambino, è di non rinunciare alla speranza. (…) Ma l’unica cosa che gli chiederei, che gli offrirei, sarà invitarlo ad assumersi la sua responsabilità nel non perdere la speranza. E che un giorno potrà unirsi a Sulai e a me in questo viaggio della speranza. E gli consiglierò che questo viaggio, questa strada, questo percorso non sia con l’M16, non con le armi. Non puoi fare questo viaggio di speranza con le armi. E gli chiederò di perdonarmi.
Sulaiman
(…) Voglio invitare tutti coloro che ci hanno ascoltato fino ad ora, a osservare un momento di silenzio e respirare con il cuore aperto e per esprimere empatia. Ogni persona nel mondo ha empatia, ma a volte abbiamo limitato questa empatia ai nostri cari. Per non sfidare le nostre narrazioni e la nostra mente (…).
Voglio davvero sfruttare questa opportunità per (…) invitare tutti, indipendentemente dalla parte politica di appartenenza, comprese le persone che ora sostengono la guerra e sostengono la violenza, a dare qualche secondo al loro cuore, alla loro anima, (…) dare una possibilità all’empatia e all’umanità, anche in tempo di guerra. Questa è la generosità della moralità che sono certo, esiste davvero in tutte le nostre culture. E questo può davvero essere un punto di svolta per una trasformazione personale e collettiva (…)
(…) C’è davvero abbondanza, di risorse, d’amore, e di risorse materiali. E tutto ciò che ci permette di avere una vita diversa e un mondo diverso è pienamente visibile. Lo sto vedendo. Lo vedo nel mezzo delle tragedie che stanno accadendo in questo momento a Gaza e nel sud di Israele e in molti luoghi, anche in Cisgiordania. In Israele nessuno si sente al sicuro ed è un momento molto pesante, ma posso sentire e vedere in questo l’opportunità di trasformare davvero il palcoscenico per un momento storico, di lasciar perdere un po’ la vecchia storia per consentire l’esistenza di una nuova storia in cui i nostri popoli possano davvero essere pienamente se stessi, e autentici, e sentendosi in pace e al sicuro. Grazie.
Le parole di Chen e Sulaiman mi hanno riportato alla citazione di Joanna Macy: “Camminate coraggiosamente nella vita, con cuore spezzato, aperto”. Ho chiesto di condividere qualsiasi cosa sentissero come importante in questo momento.
Chen
(…) Credo che voi e la maggior parte (…) delle persone che ci stanno seguendo, la cosiddetta comunità internazionale, insomma le persone che stanno ascoltando me e Sulai, dentro di loro stanno pensando a queste barbarie in Medio Oriente, o al conflitto israelo-palestinese o a qualsiasi altra cosa, e si sentono distaccate o lontane, o qualcosa del genere; oppure (…) pensano: cosa posso fare? Qual è il mio ruolo? e così via.
E voglio ancora una volta tornare al medium teatrale (…) che mi sta insegnando molto sul mio ruolo, rispetto al palcoscenico del conflitto, e sul ruolo di Sulai, come protagonista o antagonista in questo conflitto. E quanto a voi, la gente che ci sta guardando e ascoltando e pensa che il ruolo dello spettatore sia solo quello di osservare e di rimanere passivi. Credo che il teatro (…) ci stia insegnando che non c’è ruolo senza responsabilità, che tutti noi dovremmo trasformarci nel mondo, (dal ruolo di) spettatori, osservatori, nel ruolo di spett-attori, che tutti noi abbiamo il compito di adempiere alla nostra responsabilità e di diventare attori, nel drammatico momento che ci suggerisce, o che esige anzi e di diventare attivi. E l’unica cosa che voglio dirvi è: sì, attivatevi, unitevi a noi, diventate attori sul palcoscenico del conflitto israelo-palestinese, ma non pensate che il vostro ruolo sia quello di essere pro-Israele o pro-Palestina; non è questa la storia, il copione. Il copione è che dovete essere a favore della giustizia, per l’uguaglianza, per la solidarietà. E se volete correre gli stessi rischi come Che Guevara diceva per la solidarietà, significa che devi chiederti dov’è l’arena, dov’è il palcoscenico in cui le persone stanno co-resistendo, co-esistendo, lottando insieme, ri-umanizzandosi a vicenda, e così via. (…)
Sulaiman
Aggiungo la mia voce a quella del mio fratello e amico Chen. E voglio dire un’altra cosa che riguarda la nostra gente di qui, in questa terra sacra. Mi sento pienamente, davvero nel mio cuore e non vivo in La La Land (ndt “nella fantasia”), sento che vivo pienamente nella terra di qui, dove sentiamo e vediamo e siamo testimoni, sperimentiamo in prima persona la fame, la violenza, l’occupazione. Se vengo qui a Betlemme per stare con un mio amico, devo passare un check point, non so se ci arriverò, se potrò tornare indietro (…). Anche sulla polarizzazione (…) Siamo soliti dire qui, divisi fra palestinesi e israeliani, che viviamo in film diversi. (…) Poiché ho imparato la lingua ebraica, posso ascoltare le notizie da entrambe le parti ed è una storia completamente diversa! (…) C’è davvero la battaglia è in termini di superiorità della morale. Nessuno vuole sentirsi dire o ammettere che la propria moralità è inferiore a quella degli altri, e così si perpetua la disumanizzazione.(…)
E sono felice per il movimento di risveglio che mi sembra di vedere a livello globale. È bellissimo. Davvero. Non sono d’accordo con tutti gli slogan, (…) specialmente quello che porta molto odio nel mio nome, e non voglio che questo sia nel mio nome. La mia vibrazione e quella del nostro popolo (…) non include danneggiare altre persone, soprattutto civili e bambini, (…) non include l’odio per nessun gruppo di persone. Vediamo che alcune persone in tutto il mondo, soprattutto i politici, industrie, industrie della guerra e così via, vogliono che continuiamo a combattiamo per sempre, fino all’ultimo bambino, (…) palestinese e israeliano.
E io mi auguro che venga un momento di risveglio per i nostri popoli per essere consapevoli che come vicini dobbiamo vivere l’uno accanto all’altro, qualunque sarà l’accordo.
Quindi, in questo senso, (…) direi che personalmente sono, siamo favorevoli a qualsiasi accordo, compreso quello attuale, per lo scambio degli ostaggi, per il cessate il fuoco, ma so che questo non è sufficiente. (…) Invitiamo queste persone a sentire la vita, dove è la vita (…). Vogliamo lottare per la vita e la giustizia. Sappiamo che abbiamo bisogno di una soluzione politica e storica, più che degli accordi di cessate il fuoco, ma anche questo potrebbe essere un buon inizio (…) per (le parti) per cominciare ad aprirsi, per altre opzioni diverse da quella delle armi.
Quindi, sì, personalmente continuo a rimanere in contatto con la realtà e sono anche ottimista su una realtà diversa (…)
Siti dei Combatants for Peace:
https://cfpeace.org/
https://afcfp.org/
https://www.disturbingthepeacefilm.com/



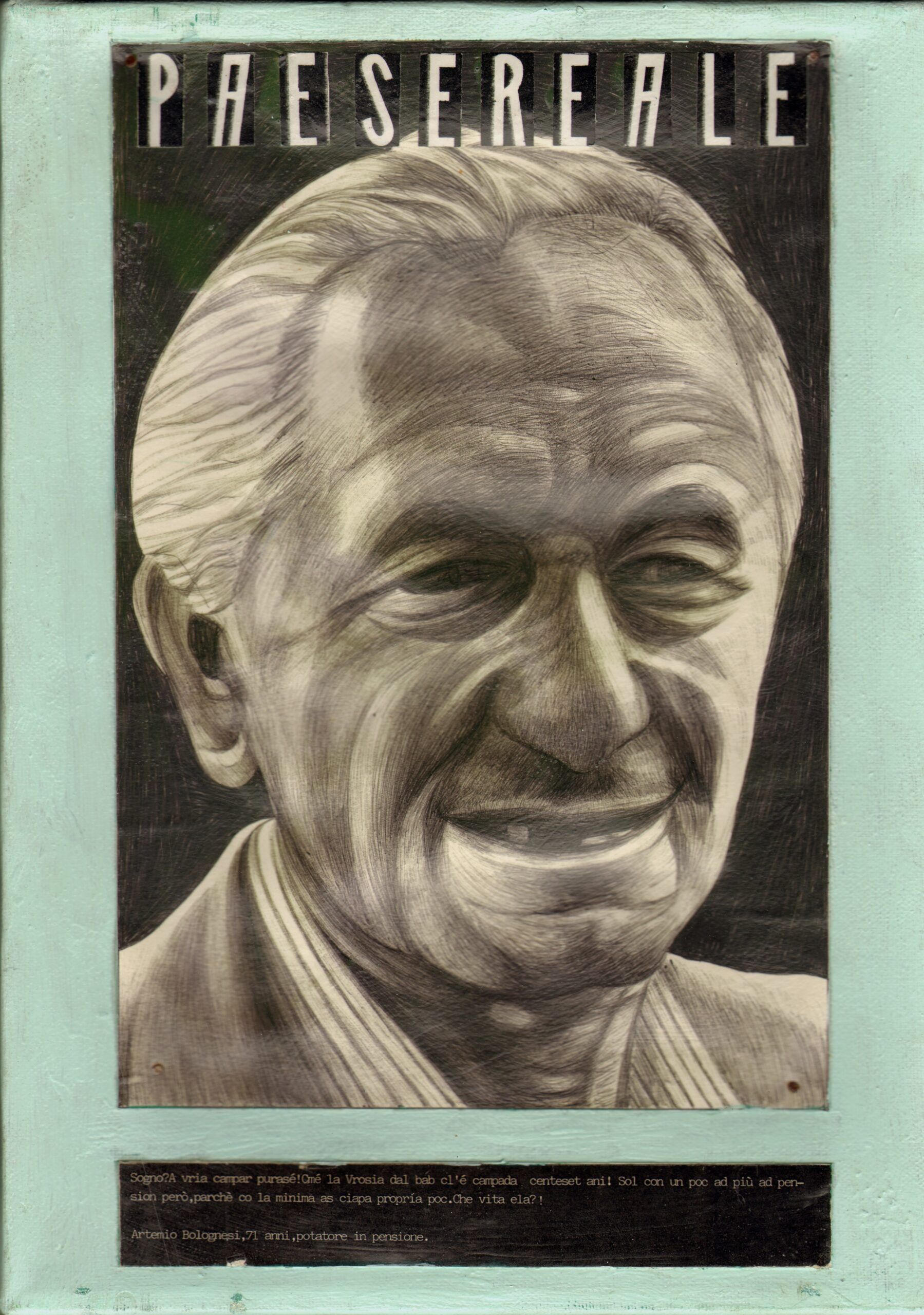
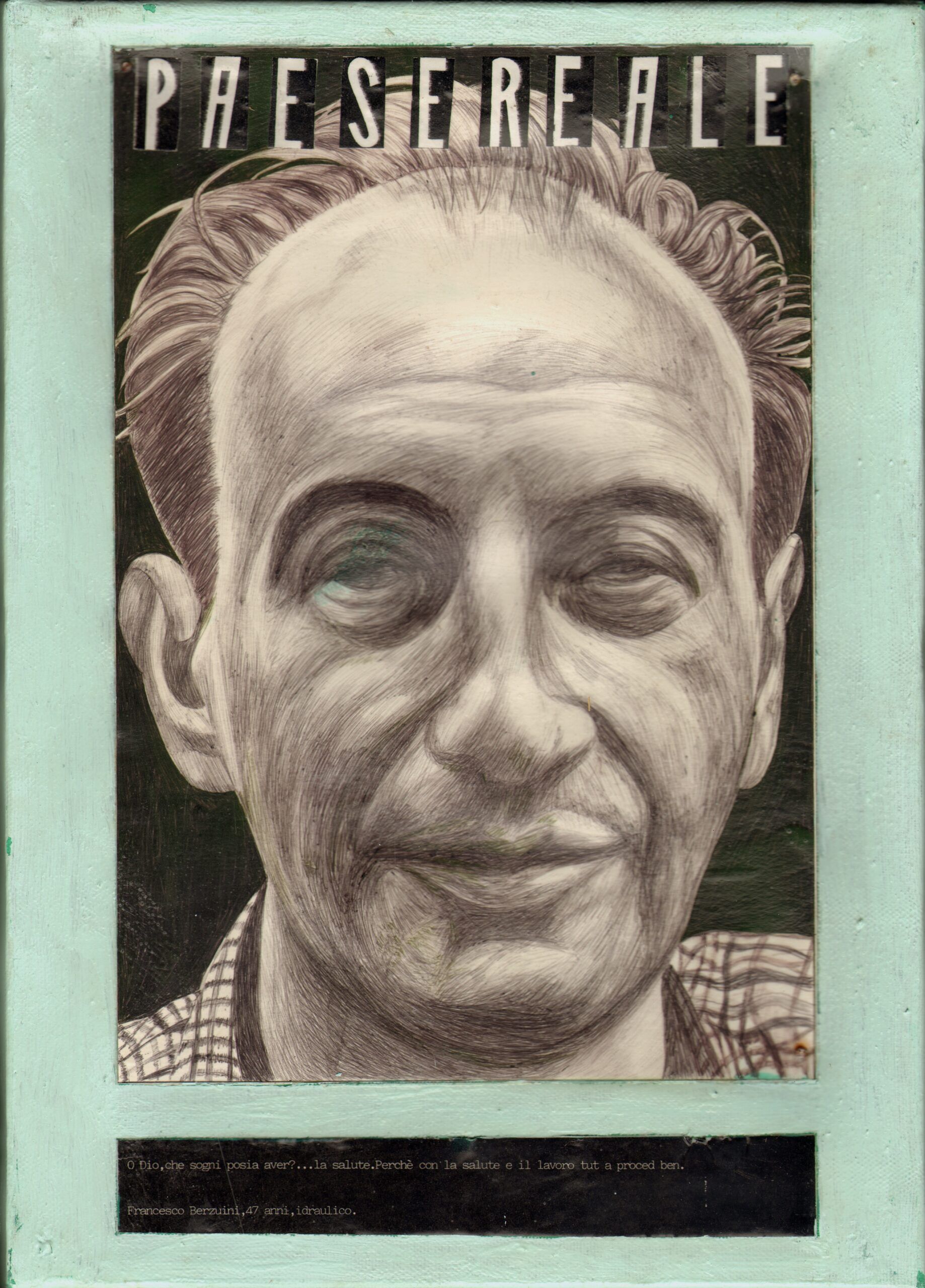










Lascia un commento