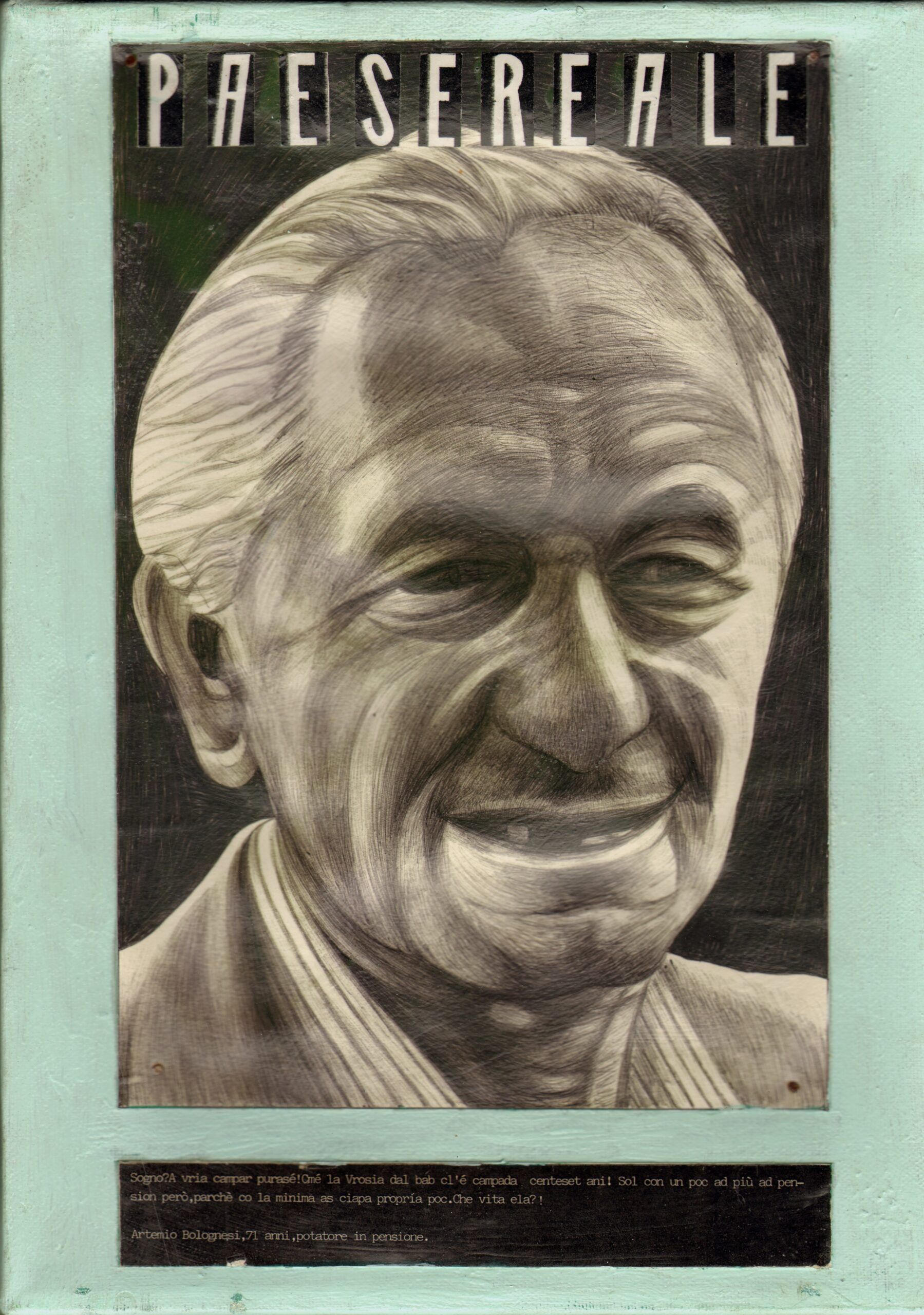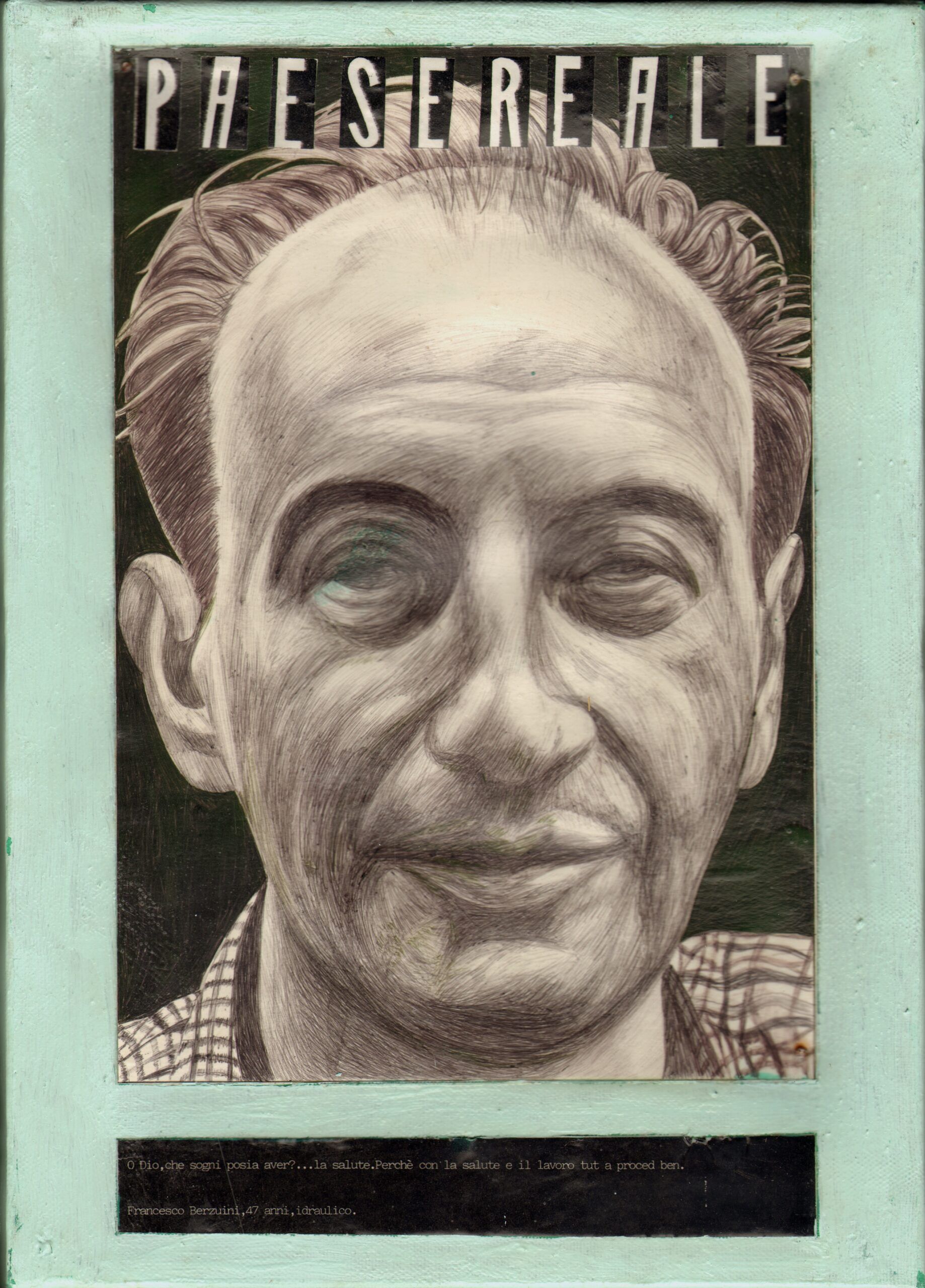Lo strano natale del satanico professor Uberzeit ci porta in giro per l’Europa e per la grande letteratura. Il racconto fantastico, ancora inedito, di Sergio Kraisky comincia oggi e prosegue nei prossimi giorni. Buona lettura.
(La redazione)
La neve cadeva lenta sulla città di Torino, cadeva da due giorni e due notti. Una neve cattiva, acerba, dicembrina. Solo quando la temperatura saliva e il ghiaccio iniziava a sciogliersi, qualche essere umano sbucava da un portone per poi arrancare tra la di fanghiglia in cerca di provviste o di qualche timido svago.
Dopo un primo entusiasmo di fronte al miracolo dell’acqua che si trasforma in neve, uno spettacolo mitologico che ad ogni inizio di stagione lo riempiva di meraviglia, il professor Uberzeit maledisse quella nevicata. Perché quell’uomo aveva un disperato bisogno di passeggiare e di farlo a passo veloce, tutti i giorni, per ore e ore. Era questa la sua unica salvezza dall’emicrania, dal mal di stomaco e dall’insonnia che lo affliggevano per intere giornate, a volte per settimane. Invece quelle strade scivolose lo costringevano a una reclusione innaturale dentro il suo appartamento da studente, come lui stesso lo chiamava, nel quale da tre mesi viveva.
Aveva tentato di renderlo più luminoso appendendo alle pareti delicati dipinti ad acquerello, rivestendo di tappezzeria dai variegati colori pastello le poltrone e il divano del salottino. Ma la conformazione stessa di quell’angusto alloggio, l’ingresso come un tunnel buio, le stanze dal soffitto basso e le finestre incassate nelle pareti come feritoie vanificavano quei suoi tentativi. Non gli restava che accontentarsi, non avrebbe potuto permettersi un alloggio più costoso. In un primo momento quella sistemazione così centrale, vicino alla splendida Mole Antonelliana, gli era sembrata un vero privilegio. Si era innamorato di Torino in una splendida giornata di fine settembre ed aveva deciso d’impulso di trasferirsi lì, ma era stato un amore di breve durata: presto si trovò a dover fare i conti con l’inverno torinese.
Ormai la sua principale ragione di vita, l’unica autentica gioia residua, erano i suoi pensieri, e se restava troppo a lungo rinchiuso in quella tana i pensieri cominciavano a gonfiarsi contro le pareti del cranio, si aggrovigliavano e poi esplodevano lasciandolo esausto, inebetito, per giorni e giorni. Passeggiando invece i pensieri si purificavano, prendevano il volo e gli regalavano lunghi attimi, a volte intere giornate, di gioia e di esaltazione. E lui aveva bisogno di esaltazione per portare a compimento la sua opera.
Sì, perché il professore era solo, malato di stomaco e di ipocondria, dolorante come un vecchio nonostante avesse solo quaranta anni, ferito nell’amore e nell’amor proprio, pieno di disprezzo per l’umanità e di compassione per se stesso. E lo sapeva, sapeva perfettamente che sbagliava a prenderla così, leggeva Spinoza e Schopenhauer per convincersi a cambiare umore. Ma tante volte, sempre più spesso, non riusciva ad accettare con eroica gioia il suo destino, nonostante proprio questo, andando ancora oltre i grandi maestri, predicasse la sua filosofia. Anche se ogni giorno si ripeteva a voce alta che quelle erano la sua vita e la sua natura, che toccava a lui soffrire in nome della verità, che la felicità è un bene ambito solo da uomini vili, da spiriti deboli. Che l’unica gioia a lui concessa era quella di poter formulare pensieri inauditi. E se il suo destino ormai era già stato scritto, che senso aveva lamentarsi? Non restava che accoglierlo, come l’amante abbraccia l’amata alla quale tutto si perdona. Ma si sbagliava, perché non poteva certo immaginare quello che di lì a poco quello stesso destino gli aveva riservato.
Si avvicinò alla finestra e scostò la tendina. Un sole livido illuminava a tratti gli spiazzi innevati e il bagliore quasi lo accecò. Il cielo cominciava a schiarirsi, ma non abbastanza per avventurarsi in una delle sue lunghe passeggiate. Oltre l’angolo di Piazza Carlo Alberto intravide una carrozza avvicinarsi e immaginò che fossero in arrivo visite per lui. Un pensiero puerile, patetico. Aveva sparso in giro la voce che era in viaggio per l’Italia meridionale, proprio per evitare visite e qualunque tipo di contatto con i suoi familiari o i pochi amici. Solo due o tre persone assolutamente discrete conoscevano il suo indirizzo a Torino.
L’isolamento gli era necessario per portare a termine la sua opera, sapeva che i suoi malanni e il suo umore ne avrebbero sofferto e certe volte, soprattutto di notte, veniva sopraffatto da un doloroso bisogno di amore e di amicizia. Allora cominciava a parlare da solo, si metteva a suonare il pianoforte e a cantare. Spesso gli capitava di piangere, non sapeva se per la solitudine o se per la bellezza della musica. Dopo aver visto quella carrozza passare davanti al suo portone senza fermarsi, con uno scatto tipico del suo temperamento, decise che aveva bisogno di aria, di sole, di mare. E di carne umana. Preferibilmente fresca.
Si diresse in ingresso, indossò un pesante caffettano grigio che gli scendeva fino alle caviglie, uno sciarpone blu per coprirsi la bocca, si infilò sopra il cranio dolorante uno zuccotto di lana grezza e subito sopra, per maggiore sicurezza, un cappellone nero a larghe falde. Poi, sfidando il vento gelido che saliva dalla tromba delle scale, scese in strada. Con gesto brusco fermò la prima carrozza libera e mentre vi saliva gridò al vetturino col suo forte accento tedesco: “Alla stazione centrale!”
Era un giorno di dicembre inoltrato, nel 1888..
(continua)
Seconda parte [Vedi qui]
Terza parte [Vedi qui]

Sostieni periscopio!
Sergio Kraisky
Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it