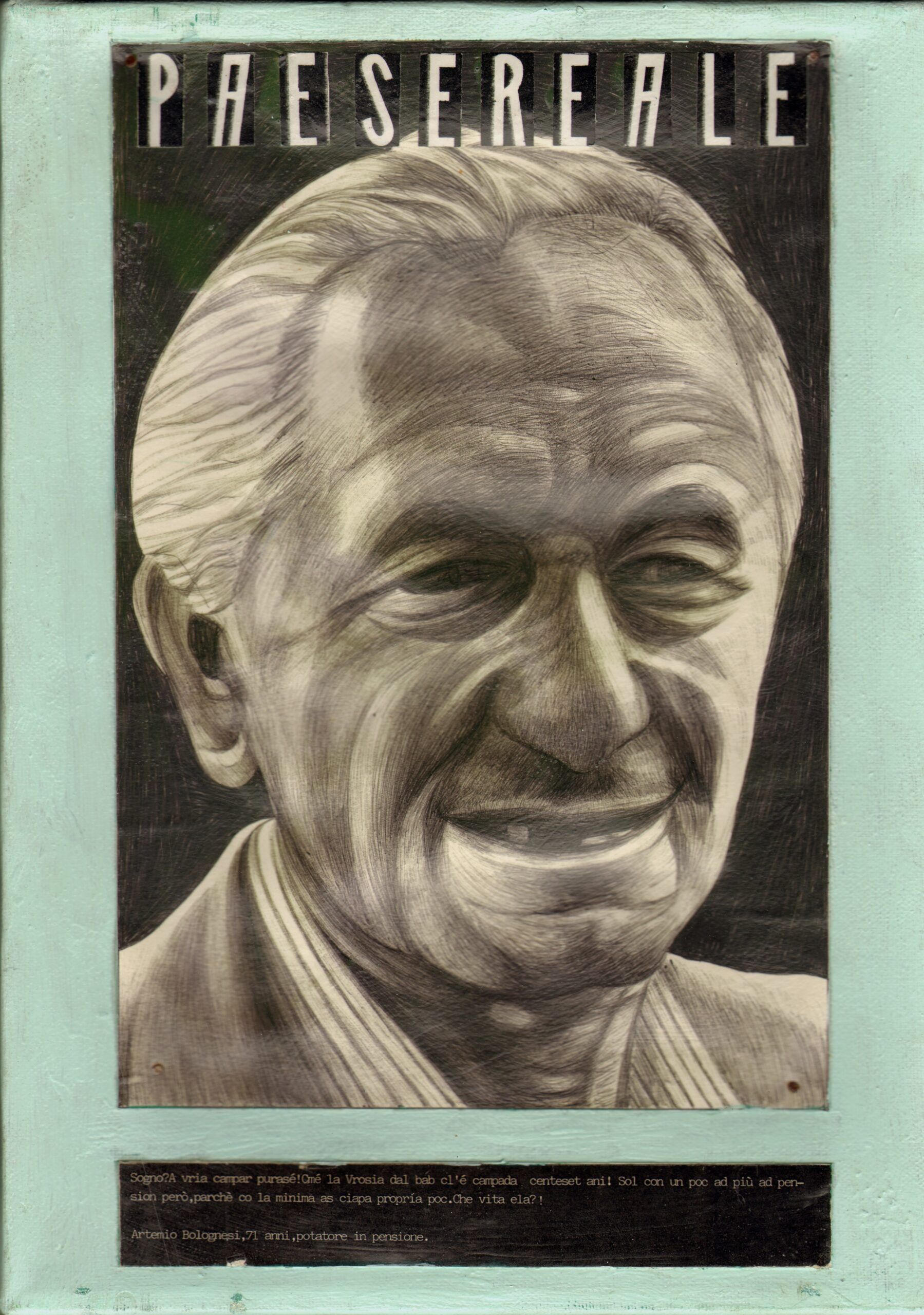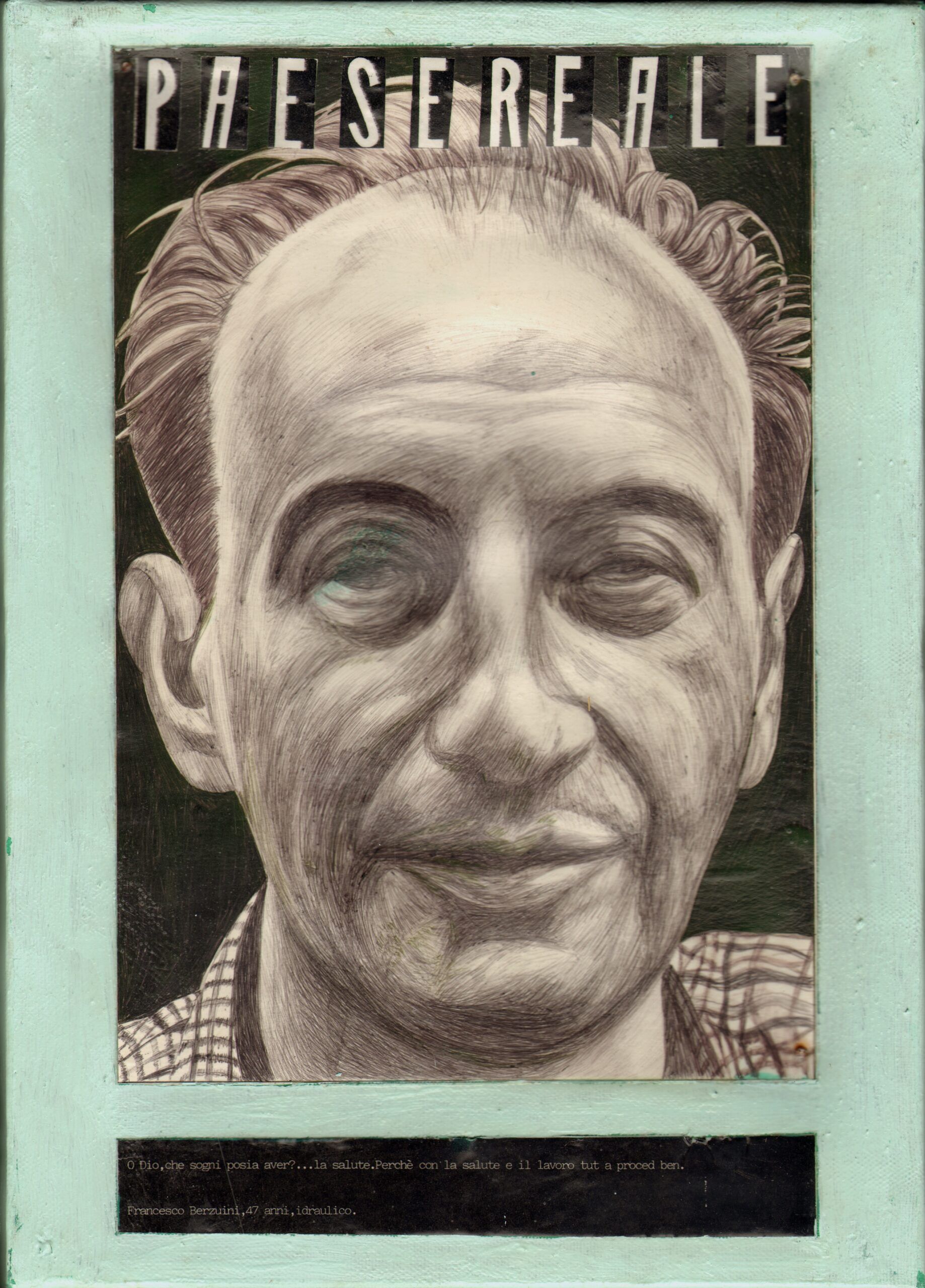PRESTO DI MATTINA
Quale Riforma per la Chiesa di oggi: ri-dare forma alle relazioni ecclesiali
Tempo di lettura: 9 minuti
«La parola non farà che tirarsi dietro altre parole, le frasi altre frasi. Così il mondo intende definitivamente imporsi» (Ingeborg Bachmann, A voi, parole (1961), in Poesie Parma 1978, 155). Un effetto trascinamento, quello descritto da Bachmann, che mi ricorda l’esperienza vissuta dalle donne nella chiesa: salite in cattedra e chiamate a insegnare alle comunità cristiane, esse si sono tirate dietro l’una con l’altra, coinvolgendo le donne altre donne.
Se ne trova conferma aprendo il sito del Coordinamento delle Teologhe Italiane (www.teologhe.org), dove ho trovato l’indicazione di un libro che racconta la storia e l’iconografia del monastero di sant’Anna a Foligno. Vi si narra di un gruppo di donne terziarie francescane che, invece della clausura, scelsero la via della testimonianza del vangelo per le strade della città, accanto alle persone bisognose. Non lasciarono scritti, ma il loro ‘magistero’ fu impresso negli affreschi che commissionarono. Tra questi, emblematico quello che raffigura una inconsueta immagine di Maria bambina che insegna ai dottori nel Tempio e quella del piccolo Gesù che viene circonciso da una donna; come a dire lo stile del loro porsi come discepole di Cristo.
Il CTI valorizza e promuove in prospettiva ecumenica gli ‘studi di genere’ in ambito teologico, biblico, patristico, storico, favorendo la visibilità delle teologhe nel panorama ecclesiale e culturale italiano e sostenendo le donne che desiderano dedicarsi allo studio della teologia. Così ho seguito in streaming le relazioni del recente seminario di coordinamento delle teologhe: Riformare si può, che ha tematizzato la possibilità di un cambiamento di rotta a condizione di “ri-dare forma” alle relazioni ecclesiali. Nessuna riforma dei procedimenti istituzionali potrà mai essere raggiunta infatti se non è preceduta e accompagnata dal rinnovamento della coscienza delle relazioni reciproche tra i cristiani, e se la Chiesa non inizierà a cogliersi anzitutto come luogo di relazioni fraterne e sororali. Ma la conversione della coscienza non basta. Così questa deve avviare pratiche e istituzioni che facilitino tali relazioni: quelle fra chiese locali, tra ministri e laici, uomini e donne, poiché nella simbolica del Corpo di Cristo la chiesa non potrà essere tale a prescindere dalla concretezza dei rapporti e dal coinvolgimento di genere. I cristiani, infatti, sono soggetti organici, collettivi, reali di questo corpo e vivono le loro relazioni in forza di uno spirito comune che anima il corpo e lo rende agente secondo le particolarità di ogni parte. Non già dunque come tante vite semplicemente accostate l’una all’altra, ma generando un’unica indifferenziata esistenza che si distingue – come ci ricorda l’apostolo Paolo alludendo alle membra del Corpo – solo per i diversi doni che lo spirito dona a ciascuno.
La via da percorrere ci viene indicata nel capitolo 18, 1-4 di Matteo, là dove si ricorda un assillo dei Dodici che continua a echeggiare anche oggi nella chiesa: «Chi è il più grande nel Regno dei cieli?». Un interrogativo raggelato dalla risposta di Gesù che, nello spirito del Vangelo, replica: «se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete… chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli». Il vero è infatti che ‘farsi grandi’ costituisce per il cristiano una contraddizione che lo rende incoerente di fronte al vangelo che vuole testimoniare e nell’ambito della Chiesa una malattia mortale, che scardina la comunione ecclesiale e fa ammalare il corpo terreno di Cristo. Così la ricerca della grandezza diventa lo scandalo, l’inciampo di ogni serio tentativo di riforma della realtà ecclesiale. Al contrario il farsi piccoli libera e attiva dinamiche spirituali di crescita, creando la premessa paritetica di una reale osmosi (Cfr. Nicoletta Gatti, Perché il «piccolo» diventi «fratello»: la pedagogia del dialogo nel cap. 18 di Matteo, Tesi Gregoriana PUG, Roma 2007).
Come quella volta che dalla ferita del costato trafitto del crocifisso, il suo essere diventato il più piccolo di tutti, scaturirono sangue ed acqua, simbolo del battesimo e dell’eucaristia che determinarono la nascita della chiesa, così anche oggi la rinascita della chiesa chiede un’altra ferita: una ferità d’umiltà. Ce lo ricorda un testo poetico di Agostino Venanzio Reali, che fa luce sui differenti atteggiamenti e pratiche invalsi tra i cristiani: taluni generativi di un disamore disgregante proteso verso il nulla; altri, scaturiti da una “ferità d’umiltà”, e quindi capaci di rompere il cerchio del clericalismo e del maschilismo ecclesiale, che mortificano e frenano la costituzione del popolo di Dio attraverso l’unica e autentica dignità di cui vantarsi, quella derivante dal battesimo, generativa di sororità e fraternità: «C’è chi bruca il fior di loto,/ chi la morte chi il nulla./ C’è chi tenta imporre limiti,/ i propri, all’infinito./ C’è chi approda al buio silenzio,/ alla fine assoluta./ Pochi ormeggiano se stessi/ alla roccia di Cristo,/ perché pochi amano/ la ferita d’umiltà./ E tu avresti per tutti/ luce e calore. Aiutaci/ a rompere il cerchio/ del nostro disamore» (Primaneve, Castel Maggiore BO 2002, 87).
Ri-formarsi deve essere dunque una prassi costante se si vuole continuare a vivere anche per la Chiesa; essa non ha mai stata un’identità statica, monolitica, e la fede non si è mai identificata con un modello di società, di cultura; incarnandosi in esse ha poi saputo andare oltre, facendo tesoro di quanto recepito e vissuto, così come accade nelle età della vita di una persona e nello sviluppo di una società che si evolvono. La forza che ha permesso alla chiesa di non identificarsi o sottostare a imperativi ideologici, a classificazioni culturali, a modelli sociali del passato sono stati lo spirito e l’evento conciliari (Ad gentes 22); oggi l’invito ci viene dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium che costituisce l’avvio di un processo di riforma della mentalità e delle prassi ecclesiali nelle relazioni ad intra e ad extra della chiesa.
In particolare il concilio Vaticano II – non diversamente da quanto sta provando a fare anche papa Francesco – ha messo un freno al clericalismo, che riduce l’azione della chiesa a ciò che possono fare solo i “chierici”, generando così una frattura nel popolo di Dio con i laici. Provoca grande danno la convinzione di molti “clerici” che tutto ciò che è essenziale per la vita della chiesa sia posto nelle loro mani. Il risultato è una chiesa suddivisa in docenti e ‘discenti’, con i primi resi miopi e autoreferenziali dal compito del ‘dare’, e inconsapevoli delle preziosità che potrebbero ‘ricevere’ e generarsi da ogni vita di fede. È proprio per scongiurare questo rischio che il Concilio ha voluto recuperare la categoria di popolo di Dio, e con ciò la massima dignità di tutti i battezzati, indicando chiaramente nella reciprocità di tutti i ministeri – al modo della diversità delle membra di un corpo – la struttura portante della Chiesa: nella quale anche il ministero ordinato deve essere al servizio, e non in posizione di potere, rispetto al ‘sacerdozio comune’, cui sono chiamati tutti indistintamente i fedeli in ragione del loro battesimo.
Non meno dannoso, per la chiesa, e poi il maschilismo che la pervade, tanto più quando ne vengono sacralizzate le dinamiche. Eppure, Gesù seppe vivere la sua mascolinità senza generare maschilismo, come esperienza umana parziale, non ponendosi in una posizione dominante, ideologica, ‘onnipotente’ rispetto all’altro che incontrava – donne, bambini, emarginati, ammalati, stranieri; accogliendoli come un dono, compagni di viaggio, compagnia del Regno che non si impone ma viene fiducioso come il granello di senape e il lievito nella pasta. Rifuggendo da ogni logica di dominio lo stile di Gesù fu quello farsi da parte, farsi piccolo, riaprendo spazi all’altro, ri-dandogli la parola, la vista, il cammino, la liberazione dal male; così facendo, non andarono perdute la dignità e la grazia racchiuse nei piccoli presi da lui a immagine del Regno dei cieli e a modello per i discepoli. Basta leggere il vangelo per cogliere quanto dirompente sia stata, per l’epoca, l’azione di contrasto ed educativa esercitata da Gesù verso la mentalità discriminante dell’epoca, presente nei suoi stessi discepoli e quanto esplicita fosse stata la volontà di conferire pari dignità alle donne che incontrava: fermandosi, parlando con loro e ricevendo dalla loro stessa fede e cura, una comprensione più ampia di se stesso, della sua umanità e missione e della prossimità di Dio, tanto da esultare di gioia nello Spirito santo. (Lc 10,21)
Serena Noceti docente di ecclesiologia in un incontro a Ferrara ci aveva ricordato che «il processo di riforma si svolge a tre livelli: quello dell’autocoscienza collettiva (una conversione condivisa nel modo di guardare la realtà); quello del cambiamento dello stile interno, delle modalità delle relazioni e della figura esterna (cosa viene percepito); quello delle modifiche strutturali, organizzative. Non si tratta di dedurre da un’idea forme e strutture. Ciò che fa sorgere la riforma è la discrepanza tra le strutture esistenti e i desideri dei soggetti; tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto; tra le strutture formali e quelle informali. Quando la discrepanza diventa evidente, la riforma diviene possibile».
E questo può avvenire non a partire da un’idea e men che meno da una teoria, ma attraverso l’elaborazione e la proposta di narrazioni di storie vissute che evochino esperienze significative, già praticate o almeno desiderate. Storie narrate in una molteplicità di forme, capaci di intercettare le diversità che si incrociano sulla soglia o sul confine ecclesiale, rese visibili da ‘testimoni narranti’, i cui racconti siano capaci di innescare non tanto un pensare comune quanto una vita comune, vissuta insieme a partire da quelle storie esistenziali: «Storie – direbbe Serena Noceti – non assertive ma performative, che fanno quello che dicono, ovvero in grado di attivare delle dinamiche e dei processi». Così ho pensato ad una storia di sinodalità: Polenta conviviale. Un racconto africano narrato da don Alberto Dioli quando era missionario in Congo. È il racconto di una vecchia tartaruga che riuscì a superare, là dove i grandi animali della foresta avevano fallito, con stile sinodale, le prove che Dio aveva richiesto per darle in sposa la figlia.
«Tanto tempo fa Dio viveva con gli uomini sue creature. Egli aveva una figlia molto bella e volle darla in moglie a qualcuno che fosse degno di lei. Egli disse: colui che riuscirà a cucire questo vestito lungo 300 metri sposerà mia figlia. L’elefante si presentò per primo e ricevette da Dio una lunga pezza di stoffa. Si mise al lavoro immediatamente. Ma non aveva ancora terminato i primi tre metri che si scoraggiò, abbandonò il lavoro e partì senza neppure prendere congedo. Il leone pretese di riuscire, ma non fece meglio dell’elefante. Arrivarono gli altri animali della foresta, ma non ebbero migliore fortuna. Una vecchia tartaruga, informata della disavventura toccata ai suoi fratelli animali, disse: “Che posso fare per sposare questa bella ragazza?”. Dopo aver riflettuto a lungo prese un grosso recipiente, vi nascose dentro 299 tartarughe, lo richiuse con diligenza e si mise in viaggio. Strada facendo incontrò il vecchio elefante. “Dove vai figliolo?” chiese l’elefante. “Caro padre, rispose la tartaruga, ho saputo che Dio ha una bella figlia da maritare e io vorrei essere il fortunato che la sposa”. L’elefante rise di gusto: “Abbiamo fallito noi grandi e forti, riuscirai tu piccolo come sei?”. Rispose la tartaruga: “Non rinuncerò prima di aver tentato!” … E continuò il suo viaggio verso il villaggio dove Dio abitava. Anche gli uomini, avendo saputo lo scopo del suo andare, fecero i loro commenti definendo la tartaruga: animale stolto e presuntuoso. Quella sera ebbe da mangiare e da dormire. La mattina dopo Dio le diede la pezza di stoffa di 300 metri. Allora essa distribuì le tartarughe lungo i 300 metri e a ciascuna assegnò ago, filo e … un metro di lavoro da fare. Cucirono, cucirono talmente bene e senza rumore che prima del tempo stabilito il lavoro era finito e la gente credeva che la tartaruga avesse fatto tutto da sola. L’animale trionfante portò allora il lungo vestito a Dio, tra la meraviglia generale. Dio allora diede ordine di uccidere 300 galline e di preparare 300 piatti di bugali (il bugali è una specie di polenta fatta con farina di manioca e tiene il posto del nostro pane alla mensa dell’africano). Quando tutto fu pronto disse che la tartaruga doveva mangiare tutto quel cibo nello spazio di un’ora, altrimenti non avrebbe visto la sposa. La tartaruga distribuì ancora il cibo tra le sue 299 compagne e dopo mezz’ora il bugali era finito. Dio allora diede alla tartaruga la bella figlia come sposa e per tre giorni e tre notti la foresta risuonò di canti e di suoni di festa. Insegnamento: anche i piccoli e gli ultimi possono riuscire … se stanno uniti».

Sostieni periscopio!
Andrea Zerbini
Chi volesse chiedere informazioni sul nuovo progetto editoriale, può scrivere a: direttore@periscopionline.it